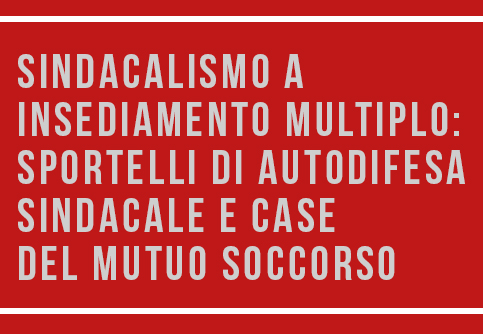In preparazione della manifestazione a Roma di domani – 23 marzo – per il clima e contro le grandi opere inutili, pubblichiamo questa riflessione sul contributo dell’agroecologia ad una pratica per la possibile trasformazione delle politiche neoliberiste e di distruzione dell’ambiente.
di Carlotta Ebbreo
Fino a poco tempo fa, ci sembrava difficile intenderlo. Difficile intendere cosa volesse dire lottare contro il cambiamento climatico, o meglio contro l’influenza umana sul cambio climatico. Era forse troppo complesso, e per questo risultava meno efficace e con meno possibilità di produrre consensi, rispetto ad altre spinte politiche. Sicuramente più facile era ascoltare un’altra storia, subirla con lentezza e per generazioni. Era una storia che raccontava che si poteva “generare ricchezza” nei territori in maniera “semplice”.
Ad esempio, semplicemente, estraendo risorse naturali e devastando dove le voci dei popoli sembravano fare poco rumore. Ad esempio, utilizzando la forza lavoro di coloro che, al nord e al sud globale, erano così sfruttati che dello sfruttamento in più poteva quasi essere raccontato come un’opportunità lavorativa.
Ad esempio ancora, credendo che si potevano produrre alimenti con l’agricoltura industriale e venderli nei supermercati, a costo di erodere risorse naturali ed ecosistemi, ma anche sistemi economici locali. Era più semplice, ad esempio, proporre come una vittoria della modernità modelli di produzione e distribuzione del cibo che consumassero tanta di quella energia che era facile pensare che avevano bisogno di nuove infrastrutture energivore, come nuovi gasdotti, nuove trivellazioni, trasporti più veloci, più strade e più grandi. E poi era così semplice pensare che i territori dove si poteva fare esperienza delle colline e delle montagne, dell’acqua o della produzione sana, dovessero diventare sempre meno, sempre più esclusivi e soprattutto destinati ad una fascia di popolazione abbiente che potesse farci le vacanze, piuttosto che alla vita quotidiana.
Le imprese occidentali hanno potuto farlo a latitudini diverse del mondo, contribuendo a generare catastrofi, conflitti e povertà sociale, che in buona parte del mondo forzano le persone a spostarsi altrove, a migrare. Adesso possono dire che la crisi della crescita è così importante che devono farlo ancora. Nuovi territori dove si può produrre violenza per scacciare i popoli che han custodito un luogo, erodere le risorse naturali, e così la possibilità dei popoli di restare e vivere in maniera degna, senza dipendere dal mercato per mangiare, curarsi, sopravvivere. “Illusione metafisica” dicono alcuni [1], parlando di questa illusione che il profitto economico si poteva generare noncuranti del contesto materiali in cui questo si sviluppava. L’illusione di poter estrarre valore, distruggere territori e, riferendosi a tutto questo, parlare di ricchezza. Questa organizzazione e forma di raccontare riguardo l’estrazione di materia viva, ovvero le vite umane e non umane, come risorse trasportabili e da trasportare, ricollega il sistema del cibo ad altri sistemi di produzione, deturpazione e sfruttamento, tipici della logica neoliberale. La “battaglia” del nuovo governo per la crescita attraverso le “grandi opere inutili” appare confermare la scelta di questo “cammino semplice”. E questo spunto, non solo ci fa arrabbiare, ma ci fa cominciare a chiarire i nostri dubbi.
Dall’America Latina arrivò qualche anno fa il concetto di “zone di sacrificio”, ovvero territori che devono prestarsi all’efficienza e alla produttività. Il sacrificio, è quello di persone e popoli che lo abitano rispetto alle condizioni che un territorio offre per organizzarsi in comunità. Sacrificare autonomia per le necessità più immediate, come l’acqua, il cibo, l’aria; la possibilità di mantenere uno stile di vita degno, e sostituirlo a una dipendenza dal mercato, da altre zone di sacrificio, altre persone, chissà dove. Nelle zone di sacrificio, il valore che danno le popolazioni che le vivono, non vale niente. Quest’ultimo va spogliato, discreditato, deriso, a discapito di quello si può estrarre da questi territori vendendoli sul mercato. Gli studiosi argentini Svampa e Viale parlano quindi di un modello di “sviluppo” il cui consenso è basato sulla sua finalità di produzione di beni di mercato [2].
Avendo fatto, tra le altre, queste considerazioni, abbiamo deciso da un po’ di tempo, di cominciare a pensare ed ad agire in maniera meno semplice. La spinta da cui nasce questa scelta, possiamo ammetterlo, forse è una “credenza”. Non si desidera per nessun@ di vivere zone o vite di sacrificio, nemmeno a noi stess*. Si crede che non sia giusto continuare a guardare all’aumento delle diseguaglianze sociali, dello sfruttamento delle persone e dei territori, chiamando le decisioni politiche ed ingegneristiche che permettono di farlo “investimenti per la ricchezza”. L’investimento guarda al futuro, la ricchezza necessità equità e fattibilità ecologica altrimenti è entropia. Questa ricchezza costituisce strutturalmente ingiustizie ambientali, che infliggono estrazioni a catena, nel valore della vita delle persone e dei loro ambienti naturali. Queste ingiustizie sono un punto cardine di una dominazione ecosociale del capitale sulle persone, perché riducono la possibilità di organizzarsi diversamente dalla formula semplice vivo/consumo/muoio. In proposito di questa ricchezza promessa, spesso attraverso opportunità lavorative, il pedagogo brasiliano Paulo Freire, ci fornisce forse una chiave di lettura “[…] il potere degli oppressori, quando cerca di rendersi gradito alla debolezza degli oppressi, si esprime quasi sempre come falsa generosità, senza arrivare mai a superarla. Gli oppressori, falsamente generosi, hanno bisogno che l’ingiustizia perduri, affinché la loro “generosità” continui ad avere le occasioni per realizzarsi. L’ordine sociale ingiusto è una fonte da cui sgorga perennemente questa falsa generosità, che si alimentare con la morte, lo scoraggiamento e la miseria".
Ancora Freire ci diche che "[…] Gli oppressori uccidono la vita nella misura in cui per dominare, tentano di frenare l’ansia di ricerca, l’inquietudine, il potere di creare che caratterizza la vita.” [3]
Ci si prende di forza e capiamo che le pratiche agroecologiche sono un’impresa semplice in un contesto complesso. Riorganizzare i sistemi di produzione del cibo a partire da coloro che ci lavorano, da principi di ecologia e solidarietà, non è facile. E’ una lotta per difendere la vita, in tanti aspetti di riproduzione della relazione simbiotica con i nostri ambienti naturali, che cerchiamo, nei contesti plasmati di “occidente”, di costruire non sempre a partire da tracce sufficienti di memoria.
Forse uno degli aspetti difficili è transire da un sistema del lavoro basato sull’idea fittizia di responsabilità individuale sulla sopravvivenza, a una forma del lavoro in cui la posta in gioco per l’organizzazione della vita è collettiva, cooperativa, interdipendente. Forse, un altro, è che non è facile passare dal pensare nel breve termine, per la sopravvivenza, al trovarsi a programmare per un termine più lungo delle nostre vite. In questo ha probabilmente contribuito che nelle esperienze di alcun* di noi la vita precaria, quasi presentista, ha avuto impatto sul senso del tempo che si accumula nelle pratiche che portiamo avanti, e nelle cose. Forse, per alcun* di noi, è anche difficile vivere vite semplici, non piene di quella intensità di rapporti e scambi tipici di uno stile di vita ecologicamente energivoro. Le trasformazioni, nella pratica agroecologica, spesso vanno lente quanto il tempo che ci vuole a fare le cose, e chi ci si dedica necessita spesso uno sforzo per consegnarsi al fatto che sta operando in una piccola parte di quel sistema di ingiustizie concatenate.
Ma è una parte basilare, essenziale, dipendente, come altre, da altre pratiche per funzionare. Questa coscienza di interdipendenza da altri fattori, come l’accesso alle risorse naturali, il loro status, la solidarietà umana e il riconoscimento mutuale degli sforzi con altr* difensori della vita, ci rimette al nostro piccolo posto.
Nell’agroecologia si tende a ricercare un’altra forma di produrre, tessere relazioni, pensare il lavoro e il territorio, e lottare per contribuire a creare vita, alimentata credenze di equità e trascendenza. La riorganizzazione agroecologica del sistema del cibo quindi, è una delle sfide, politiche, umane e “forzatamente” collettive, che contestualizza attraverso la prassi la critica all’influenza umana nei cambiamenti climatici. Ovvero, cerca di ripensare gli scambi, il lavoro e il valore, diversamente dalla logica neoliberale per cui la produzione è impostata in tal maniera da influire sui cambiamenti climatici. Si prova a fare una parte, non il tutto, questo è chiaro. Il resto spetta ad altre pratiche di cambiamento e resistenze alla forma neoliberale di organizzare la ricchezza (e la povertà), al comprendere con queste i punti di interconnessione possibili.
L’agroecologia, in aree del mondo come la nostra, è in fase di sperimentazione, proprio perché i principi di valore sui quali si colloca, vengono ancora denominati come alternativi, ed in molti casi, sovversivi. La sperimentazione di come costruire alleanze e sistemi di vita basati su questi principi ci fa ripiombare nella complessità di dover costantemente guardare alle relazioni tra diversi livelli, tra i luoghi, tra le istituzioni del potere e il potere delle istituzioni, tra i soggetti che diversamente lottano per la vita, assestare queste relazioni di scambio e valore e convertirle in prassi.
Come diceva Freire, “la pratica senza la teoria, ci mantiene oppressi, la prassi ci serve invece per esprimere il nesso tra azione e riflessione e, identifica l’azione degli uomini e delle donne sul mondo per trasformarlo” . [4] L’espressione “rivoluzione molecolare” [5] è utilizzata dal filoso Guattarie per parlare del livello di compenetrazione in ogni atto della vita e del pensiero, di una lotta contro un nemico più intimo di quanto siam portati a credere, che si necessita per contrapporsi al sistema capitalistico nella prassi quotidiana. Intendere come lottare in forma più sistematica contro il modello neoliberale di organizzazione della produzione, e le sue più o meno evidenti conseguenze, ci appare complesso, ascoltare ancora la credenza che il benessere parziale e temporaneo che porta può essere condiviso risulta semplicemente impossibile.
[1] L’espressione viene proposta dagli ecologisti politici Manuel Gonzales de Molina e Victor Toledo nel libro Metabolismos, naturaleza e historia. Hacia una teoría de las transformaciones socioecológicas, 2012, edizione ICARIA (in spagnolo)
[2] Il concetto viene formulato da Mariastela Svampa e Enrique Viale, (2014), Maldesarollo, disponibile online al https://rosaluxspba.org/wp-content/uploads/2018/05/Svampa-para-web-con-logo.pdf (in spagnolo).
Ripreso anche dall’articolo di Talarico e Salaregui Diez, (2018), nella rivista spagnola El salto, disponibile al https://www.elsaltodiario.com/explotacion-laboral/sistema-agroalimentario-fresas-y-agroecologia?fbclid=IwAR11f9r5VNJAe6o2Z1pKJjrLeK5aT6vEku5dI1za6Eao22u0UHWRGxR8Ll4 (in spagnolo)
[3] Da Pedagogia degli oppressi di Paolo Freire, nell’edizione Gruppo Abele 2018, rispettivamente pagine 49 e 66
[4] Dall’articolo Pratiche di costruzione condivisa del sapere nel centro Freire di Padova Un esercizio autoetnografico disponibile al link https://educazioneaperta.it/archives/1781
[5] Rivoluzione molecolare La nuova lotta di classe è di Feliz Guattarie, scritto nel 1978 (edizione italiana Pigreco, 2017), un primo testo per avvicinarsi al filoso consigliato è Le tre ecologie (1989, edizione italiana Sonda, 2013)