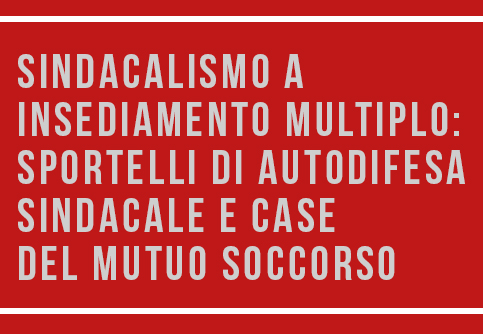Se a Partinico si può, ovunque si può
Giulio: “Nel giardino mio ci dovete fare una piccola piscina per le palline e poi uno scivolo alto fino al cielo e poi per favore niente macchine, formiche e case”. Noi: “Perché le formiche che fanno? Facciamole rimanere…” Giulio: “Va bene dai le formiche possono stare, però per favore andiamo dai signori che hanno le case e gli dicete per favore andate in un altro posto perché qui stiamo costruendo il giardino delle emozioni”. Nel frattempo passa una vicina e Giulio prende un volantino dalle nostre mani, su cui c’è scritto semplicemente: “Viviamo l’arena solidale-Let’s live the solidarity arena”, e le dice: “Maria martedì prossimo devi venire all’assemblea al giardino perché stiamo facendo una festa per i bambini”.
Martina Lo Cascio
Questo articolo è stato pubblicato sulla rivista "Gli Asini", numero 57, Novembre 2018.
Giulio è un bambino del quartiere dove si trova l’ex-Arena Lo Baido di Partinico; il 7 ottobre è programmata una festa, per iniziare a viverla e farla diventare “la piazza della Solidarietà”.
Ci troviamo in un paese di circa 32.000 abitanti della provincia di Palermo, un posto con una disoccupazione giovanile del 49%, con un’emigrazione di circa 5500 persone solo dell’anno 2017. Con le strade piene di rifiuti, con un comune in dissesto, con un servizio sanitario sempre più scadente (quest’estate sono stati ridimensionati i reparti di Ostetricia, Ginecologia, Pediatria e Psichiatria), con 14 centri chiamati di accoglienza (4 Cas, 4 comunità per minori, 2 Sprar ordinari e 4 Sprar per minori, per un totale di circa 280 “ospiti”).
Un posto come tanti altri con tali caratterisitiche di contesto, e allo stesso tempo, in cui ci si crede speciali, quasi unici nell’impossibilità di innescare piccoli e grandi cambiamenti, partecipazione e condivisione. “Qui è impossibile fare qualcosa, la gente non è interessata, ad Alcamo (il paese vicino) o al nord, lì sì che funzionano le cose”; frasi simili le ho sentite a Campobello di Mazara, Niscemi, Nardò, Rosarno, Nicotera Marina…
A rafforzare la specialità di Partinico ci hanno pensato quest’estate innumerevoli giornalisti più o meno informati, più o meno consapevoli del ruolo che hanno giocato nella riproduzione di stereotipi, di certo vogliosi di inserirsi nel dibattito attuale che vede due fronti contrapporsi: i razzisti, populisti, violenti e gli antirazzisti, umanitari, buonisti. È in questo clima da tifoseria forse che hanno trovato incoraggiamento i partinicesi protagonisti della prima azione violenta, razzista e vile messa in scena a fine luglio.
Dieng Khalifa, 19 anni senegalese, viene aggredito in pieno giorno mentre si trova fermo sulla sua bici davanti a un Tabacchi. Alcuni iniziano con degli insulti e lo invitano ad andarsene da quel posto e in generale a tornarsene al suo paese. Lui rimane fermo respingendo così la violenza verbale ed è a quel punto che parte l’aggressione fisica di gruppo. Nei giorni successivi qualcuno dirà “è rimasto fermo come un leone”, che tradotto per altri significa che meritava l’aggressione per essersi permesso di prendere parola, resistendo in silenzio.
Parte del dibattito, in ceti e ambienti differenti, si sviluppa attorno ad un’unica domanda: “è un atto di violenza razzista o una normale azione di violenza partinicese?”. La domanda stessa nasconde la natura razzista non tanto dell’azione ma dell’interpretazione generale che tutti diamo; chiedersi se sia razzismo o meno aggredire fisicamente in sei persone un ragazzo perché sta fermo sulla sua bici nasconde l’idea che la vita di un nero naturalmente vale di meno, il diritto di un nero di difendersi comunque è più limitato del “nostro”, per non parlare del suo diritto di parola. Il nero è o da massacrare o da proteggere, non ha una sua soggettività. Al massimo, il nero, in questo caso Dieng, può dimostrare di essere talmente indifeso o buono da poter dire: “Non alzo le mani, come mi hanno insegnato gli educatori”.
L’iniziativa della Cgil Palermo che si svolgerà qualche giorno dopo l’aggressione prende il titolo ed è tutta incentrata sull’esaltazione di quella frase di Dieng Khalifa, “Non si alzano le mani”, dichiarata all’ennesimo giornalista che l’avrà tartassato in quei giorni. Nella sala del convegno sindacale perfino i migliori esperti dichiarano: “Non stiamo parlano di razzismo”; qualcuno utilizzerà questo argomento per fare un altro parallelismo improprio con la nonviolenza di Danilo Dolci.
Questo grave episodio scatena immediatamente qualcosa, nell’uno o nell’alto senso c’è un po’ di eccitazione nell’entrare a pieno titolo nel dibattito più importante del momento a livello nazionale. La mia percezione dell’accaduto in quei giorni è parziale, iper-strutturata e filtrata dalle mie lenti che in questo periodo più che mai si focalizzano su Partinico, da quando ho scelto di tornarci a vivere per dare seguito a un piccolo progetto di produzione agricola contro lo sfruttamento, che si chiama Contadinazioni. Con i miei pochi compagni, sin dalla nascita del gruppo cerchiamo di tenere insieme attività economiche sostenibili che rappresentino un altro modo di autogestire la propria vita e i propri bisogni e contemporaneamente muoverci al di fuori del gruppo per rendere generalizzabili processi simili al nostro. Questo secondo aspetto comporta spesso il lottare contro quello che non ci piace e trovare modalità e pratiche per farlo. Contro ogni appartenenza identitaria, fideistica e con parole d’ordine vuote, noi scegliamo di stare dove i legami si sono spezzati, dove il senso di comunità non è visibile, dove le parole apparentemente sono molto distanti dalle nostre, dove se ne possono inventare di nuove. Organizziamo tornei di calcio in campetti abbandonati dove è probabile che un razzista incontri un antirazzista, dove è probabile che un nero incontri un bianco e con la scusa di un rigore mancato cercherà lo scontro fisico, scegliamo di organizzare cene genuine e clandestine accessibili a tutti in luoghi attraversati da chi il cibo non ha tempo e modo di riflettere da dove venga e perché. Tutto questo lo facciamo con mille dubbi, con mille domande sempre aperte: è assistenzialismo? Se non si innescano processi partecipativi, a cosa serve tutto questo? Riproduciamo o sguazziamo in dinamiche violente e disagiate perché fa figo? Se è sfibrante per noi dal punto di vista umano, siamo sicuri queste pratiche rispecchino la nostra spinta alla ricerca di una vita migliore basata sulla centralità dei nostri bisogni e desideri? Se tutto questo spesso ci porta a sforzi di impegno talmente intensi da farci star male e da perdere ogni tanto la bussola, non sarebbe meglio ritirarsi in un luogo felice dove poter praticare la nostra idea di comunità? Alle nostre stesse domande, per il momento rispondiamo che non abbiamo altro metodo, non abbiamo altra scelta. Che solo contribuendo a ricucire legami basati sul mutualismo possiamo pensare di lottare contro lo sfruttamento del più debole, soltanto da qui possiamo costruire le nostre istituzioni, viceversa crediamo inarrestabile la guerra intraclasse riutilizzata in chiave razzista e populista da tutti gli schieramenti anche se in maniera differente.
Da quando a Partinico abbiamo un pezzo di terra su cui coltiviamo il nostro pomodoro secco, di tornei di calcio ne abbiamo organizzati due e in entrambe le occasioni sono accaduti episodi utili a comprendere quest’estate di violenza.
Il primo, nel 2017, è una rissa scattata con abitanti del quartiere adiacente allo stadio: i figli giocavano in una squadra che prendeva il loro nome, una famiglia conosciuta, un marchio. In seguito ad un diverbio fuori dal campo con un ragazzo africano, il ragazzino, con il cognome conosciuto, va a riferire a casa l’accaduto. Dopo pochi minuti arrivano tanti suoi familiari e suoi vicini di casa con bottiglie in mano e cani, urlano “dovete morire tutti a mare”, “A Partinico si more”.
In un modo in un altro alcuni dei miei compagni riescono a sedare lo scontro rimasto verbale, e riprendiamo il torneo di calcio. Le altre partite saranno molto più tese, ma a calmare e a dare l’esempio sono i marocchini che da molto tempo abitano a Partinico. Hanno perfettamente compreso lo spirito del torneo e lo dimostrano sul campo allentando le tensioni. Questo episodio e il suo epilogo da un lato ci fanno ben sperare che la giornata non sia stata vana, dall’altro fisseranno i nomi dei ragazzi “conosciuti” nelle nostre menti e i commenti di molti sul loro conto. I pochi partinicesi impegnati nell’organizzazione assieme a noi, infatti, ci tengono a ribadire: “Voi non sapete come funziona questo paese, infatti avete aperto il torneo a tutti, pure ai malacarne del quartiere”.
Il secondo torneo di calcio antirazzista si svolge pochi giorni prima dell’aggressione a Dieng Khalifa, il 23 luglio al campetto in Via Aosta. Le attività si concludono con i rigori e la cena “Bi(opo)polare” all’ex-arena lo Baido; in quest’occasione c’è qualche altra realtà associativa che decide di scommettere sull’iniziativa ma riusciamo infine a coinvolgere pochissimi partinicesi. Di fatto diventa un torneo perlopiù per migranti dei centri di accoglienza. Il tutto si svolge in un campetto della parrocchia dove ci sono dei ragazzini che fanno la colonia estiva, che ci guardano da lontano e che scappano dagli educatori per avvicinarsi ai campetti. Tra questi c’è Saimon di 7 anni.
Saimon: "Ma con questi neri che fate?"
Noi: "Giochiamo, ci divertiamo, tu conosci qualcuno di loro?"
S: "Sì qualcuno... ma sai che ci sono alcuni neri che ammazzano di pugni le persone?"
Noi: "Sul serio? Ma dove li hai conosciuti questi neri che fanno queste cose...?"
S: "No, io non li conosco ma me ne ha parlato mia madre che sta molto su internet, infatti mia mamma mi ha comprato lo spray al peperoncino e io cammino sempre con una borsetta per tenerlo con me e quando un nero si avvicina gli faccio credere che nella borsa ho giocattoli e poi gli spruzzo e scappo"
Noi: "Ma tu hai mai conosciuto questi neri a cui spruzzi?"
S: "No…"
Noi: "Ma a che sei qua, perché non ne conosci qualcuno per vedere se è vero che ammazzano di pugni le persone, dai decidi con chi vuoi parlare..."
S: "Con quelli blu e rossi che sono fortissimi…"
Corriamo per raggiungerli
Si avvicina ad Abdul e gli dice: "Ciao stai a Partinico? Mi fai un autografo?"
Abdul: "Sì certo e tu poi lo fai a me?"
S: "Eh in effetti anch'io gioco a calcio coi pulcini… perché ho 7 anni"
Si scambiano gli autografi... e Abdul dice: "Abbracciami".
Purtroppo veniamo interrotti dall'operatore del campo estivo da cui era scappato il piccolo, che infastidito e impaurito intima a Saimon di mollare Abdul e tornare dentro. Noi spieghiamo l'importanza di quello che era appena successo e lui dice: "sì ma dobbiamo andare"... Fine.
Dopo un po' ci riferiscono che ci sono dei ragazzini che ci cercano... In tanti sono scappati pochi secondi dal campo estivo, perché volevano un autografo da Abdul... Infine, arrivano gli operatori, portano un piccolo mucchietto di pezzetti di carta per degli autografi in serie per tutti i bambini.
Entrambi questi episodi dimostrano che le difficoltà e il disagio preesistevano agli eventi di cronaca, ma sottolineano anche la possibilità di uscire da una visione e pratica d’azione dicotomica che vede da una parte i sensibili umanitari e dall’altra i razzisti ignoranti. Anche chi si definisce razzista o dichiara di aver paura dei neri, di fronte alla conoscenza diretta o a un’esperienza di condivisione può dimenticare, forse per qualche minuto, ciò che ha sentito a casa o in tv. In totale contrapposizione con quest’approccio, la tendenza alllo scontro va sempre più rafforzandosi, al punto che noi stessi veniamo a conoscenza dei “fatti di Partinico di fine luglio” quando il nostro telefono comincia a squillare perché qualcuno vuole sapere dettagli succulenti da scrivere su pagine di giornali più o meno prestigiosi, altri minacciano o comunicano che il giorno dopo verranno a fare cortei e manifestazioni a casa nostra. All’inizio rispondiamo dicendo che crediamo non vada ingigantito l’episodio ma ribadiamo la necessità di un lavoro lento e di intervento sociale generale; alla terza chiamata capiamo che non possiamo ignorare che il fatto sia diventato mediatico ed è necessario non lasciare tutto lo spazio a chi non vede l’ora di citare Dolci come unico esempio di visione illuminata dopo la quale si è sviluppato solo il far west.
Militanti di professione di città ci chiedono: “Ci sono le condizioni per fare qualcosa in un posto così brutale?”, altri partinicesi dicono “che vergogna, solo qua poteva succedere”, altri ancora “Partinico non è questa perché da sempre è stata accogliente”.
Nell’uno o nell’altro caso non è ammessa l’ipotesi che non ci sia un’immagine monolitica di Partinico da difendere o da denigrare, ma che questo posto come tutte le società è un insieme di interessi che confliggono al centro di diverse idee di comunità. In questo quadro succede, però, che il fatto diventato mediatico è la scintilla che accende una possibilità che avremmo forse, comunque, raggiunto molto più lentamente e con molti più scoraggiatori intorno. A chi continua a chiamarci perché ha necessità di correre e reagire in nome dei partinicesi e mettere una bandiera, chiediamo un giorno di pazienza per fare delle telefonate ed evitare il rischio di una manifestazione senza partinicesi.
Questo giorno lo passiamo a mandare messaggi su facebook e per telefono che oltre ogni aspettativa danno luogo a un’assemblea nel tardo pomeriggio del 31 luglio, che vede partecipare decine e decine di persone. Sono di estrazione, colore e appartenenza diversa, sicuri però di essere antirazzisti. A quel punto per alcuni partecipanti all’assemblea era importante evitare di definirsi tali: la parola attorno a cui ci confrontiamo immediatamente è la solidarietà e non l’antirazzismo. Siamo in quei giorni tra due fuochi, chi ci vuole antirazzisti e chi ci vuole razzisti e violenti, noi in assemblea cominciamo a parlare della possibilità di andare oltre le responsabilità individuali e parlare delle cause della violenza che ci circonda e del fatto che su queste vogliamo e possiamo intervenire. È vero che molti legami sono spezzati, per questo crediamo che uno scontro tra fronti non serva; un corteo, un presidio, un convegno antirazzista potrebbero perfino spezzarne altri, di certo non creerebbero nessuna occasione di incontro con bambini come Saimon e i suoi genitori.
La parola comunità, per quanto scomoda, sfruttata, con molti siginifcati ed equivocabile, è comunque utile e da proporre in assemblea anche solo per dire che una comunità non esiste in natura e che ne siamo tutti parte e responsabili. Si comincia a parlare della necessità di una Partinico basata sull’incontro di tutti quelli che qua vogliono costruire le proprie vite su basi di solidarietà e mutuo aiuto. Qui non si tratta di cadere nella logica funzionalista che porta a dire che gli stranieri sono una risorsa, si tratta di una comunione di intenti tra persone.
All’inizio del mio interesse per la conoscenza di ragazzi che approdavano nelle nostre coste, mi ritrovavo con un collettivo universitario ad accogliere tunisini scappati dal loro paese nel 2011; ci colpiva molto sentirci dire che non avrebbero mai pensato di rimanere lì dove ci incontravamo, in provincia di Trapani, perché erano le città del nord il loro obiettivo. Per noi che rivendicavamo la scelta di essere rimasti in università a Palermo e che un po’ forzavamo l’idea che rimanere qui era l’unico senso di far politica, l’atteggiamento dei nostri coetanei appena arrivati risultava strano, difficile da accettare. Oggi, invece, di ragazzi che sperano di rimanere a Partinico ne abbiamo incontrati tanti, a volte sperano soltanto di poter concludere il loro percorso scolastico in un unico posto, senza essere d’improvviso trasferiti in un altro centro. Ed è anche con loro e con tutti quelli che si riconoscono nella necessità di ricucire i legami di solidarietà a Partinico, che vogliamo vivere, sognare e progettare.
L’assemblea del 31 luglio lancia un’iniziativa per il 4 agosto nella piazza principale, poco abitata dai partinicesi doc che però ne rivendicano la proprietà. Su invito dell’arciprete scegliamo di farla il giorno dell’apertura della festa della Madonna del Ponte e subito dopo la messa che la inaugura. Qualcuno su facebook commenterà: “Si pigghiaro’ puru a maronna ru ponte, nta chiazza mancavano sulu i liuna e parìa l’Africa”.
Scegliamo di intitolare la festa “La solidarietà che crea comunità” e di portare in piazza elementi semplici e concreti: permettere l’incontro e la condivisione perché riteniamo sia l’antidoto alla diffidenza e al pregiudizio; dare voce e prendere parola; la solidarietà, che significa per noi fare qualcosa insieme, aiutarsi reciprocamente ognuno secondo le proprie possibilità; mettere al centro il cibo, simbolo di qualcosa di cui abbiamo bisogno tutti e a cui abbiamo accesso in maniera diversa, il cibo genuino clandestino perché tutti abbiamo diritto alle cose buone e a una vita non solo dignitosa ma bella. Nei fatti si tratta di un microfono aperto, una scaletta di massima di poesie lette dagli organizzatori, una cena con prodotti dei tanti orti dei partecipanti e la richiesta di un contributo libero per accedervi. Era importante mostrare che si trattava di una cena per tutti/e e non una cena di beneficienza per qualcuno in particolare. La scaletta è saltata, si è ingigantita; rotto il ghiaccio, in tanti avevano voglia di parlare ed esprimersi, ci siamo emozionati, abbiamo cantato, ballato e ci siamo conosciuti.
La cena è stata caratterizzata da elementi esemplificativi, forti, pieni di contenuto: infatti immediatamente si è formata una fila di cui i primi erano partinicesi che vivono la piazza, tutti avevano compreso l’idea del contributo libero e in molti hanno mangiato con pochi centesimi. Abbiamo visto atti di solidarietà immediata, alcuni sempre con pochi centesimi offrivano la cena ai propri amici di una vita o a quelli appena conosciuti, africani e partinesi doc di estrazione diversa, tutti in fila a contribuire ognuno secondo le proprie possibilità. La consapevolezza che tutto questo è successo in sole cinque giornate di preparazione, tra persone che non avevano mai fatto nulla insieme, ci dà una grande speranza che non vogliamo rimanga qualcosa di astratto ma che vogliamo tradurre in pratica subito.
Per il giorno successivo viene convocata un’assemblea all’ex-arena Lo Baido per decidere insieme come usare la piccola somma raccolta e per scambiarci opinioni sulla magia. All’assemblea invitiamo tutti, “invitiamo soprattutto chi non c’era, anche se sarà difficile rendere in parole ciò che abbiamo vissuto; invitiamo chi non ha chiaro verso chi sia questa solidarietà, e si sente scippato di qualcosa, lo invitiamo a venire per spiegargli ulteriormente che questa solidarietà riguarda proprio tutti quelli che vogliono riceverla e darla, tutti, proprio tutti; invitiamo chi crede di non essere d’accordo, chi ha ancora paura a ballare nella propria piazza con un africano che ha appena detto al microfono ‘Noi vi rispetteremo, voi sarete per noi i nostri fratelli, le nostre sorelle, le nostre madri e come tali vi tratteremo’”. Così scrivevamo nei giorni successivi, così è partito un percorso assembleare che guarda lontano.
Purtroppo però, pochi giorni dopo la nostra prima iniziativa, il nostro entusiasmo si scontra con qualcosa che, seppur non ci stupisce, ci ferisce ancora profondamente. La notte del 14 agosto, durante il tradizionale falò in spiaggia, il livello dello scontro si alza. Questa volta l’aggressione sembra proprio una spedizione punitiva, più di venti persone inseguono con le macchine e bloccano un pulmino con sei ragazzi gambiani e l’operatrice del centro di accoglienza. L’aggressione fisica ai danni degli africani è violentissima e dimostrativa.
Sin da subito le voci di paese sottolineano che gli aggressori sono dei malacarne, non rappresentativi, che però per alcuni vanno giustificati perchè in fondo danno voce a molti partinicesi che hanno il pudore di non usare delle mazze e delle pietre; per altri, invece, sono solo degli ignoranti pregiudicati. Questa distinzione classista è spesso utilizzata: il violento è considerato un ignorante-delinquente e non è recuperabile, l’antirazzismo ufficiale in molti casi non ammette sfumature o redenzione. Se sei antirazzista lo sei sin dalla nascita, per fede, perchè ne hai avuto la fortuna.
In una situazione per certi versi emotivamente schiacciante, l’eterogeneità della neonata assemblea di fronte a fatti così forti esplode tutta e in varie forme, ci si ritrova però nella pratica di piccole cose concrete. Una di queste è la passeggiata per le vie del paese per parlare con la gente, dalla quale prendiamo spunto e che ci dà l’occasione per approfondire la conoscenza tra di “noi”. Alcuni componenti dell’assemblea sono insegnanti e vogliono offire le loro competenze, sin da subito si occupano delle traduzioni in assemblea dall’inglese all’italiano e viceversa, altri vogliono presto parlare italiano per esprimersi senza timidezza, altri ancora vorrebbero organizzare delle cene per far conoscere la propria cucina, alcuni hanno fatto per anni volontariato in Africa con la parrocchia, altri cercavano un posto da vivere e un gruppo con cui passare il tempo, altri hanno fatto politica in senso classico ma avevano dimenticato il piacere di stare insieme, poi c’è chi è puparo, chi falegname, chi pittore, chi musicista, chi allenatore e passa da lì e chiede come può essere utile…
È in questo contesto che si consolida l’idea di lavorare per creare le condizioni per l’incontro attraverso la progettazione condivisa da applicare nel processo di riappropriazione di una piazza. Quel posto ha aperto un mondo, pieno di contraddizioni ma vivo e reale: è incastonata in un quartiere con mille difficoltà, dove gli abitanti non frequentano più la piazza perché al buio e piena di Nivuri, gli africani invece sostano lì per ore o intere giornate, spartendosi le zone, una panchina scassata per ogni gruppo.
Nelle settimane successive, girando e rigirando per il quartiere per coinvolgere e invitare, facciamo un incontro illuminante con il piccolo Giulio che speriamo diventi il sindaco della piazza di cui tutti saremo responsabili. Nel frattempo sono stati installati giochi per bambini, in parte acquistati con i proventi della cena altri autocostruiti con materiali riciclati, alcuni stanno raccogliendo piatti per la cena senza plastica, altri ortaggi per renderla genuina, decine di persone hanno lavorato per ripulire la piazza, l’amministrazione è stata già sollecitata e dopo tanto impegno non ha potuto fare a meno di offrire una mano e l’illuminazione. Al di là della festa, il risultato è in parte già raggiunto: stiamo già sperimentando un percorso collettivo e vivendo Partinico in modo differente rispetto a come eravamo costretti a farlo fino a poco tempo fa.
I due mesi appena trascorsi sembrano anni per l’intensità delle relazioni e delle cose fatte, quasi naturalmente il martedì è diventato il giorno fisso per incontrarci e ogni volta tante sono le idee e le persone che si avvicinano. Si è deciso per testarci di darci un obiettivo medio-piccolo e uno spazio definito su cui sperimentare: abitare la piazza. Un giornalista, che si è presentato in modo diverso e per questo è stato da noi accolto, ha scritto infine un articolo simile a tanti altri descrivendo la brutalità degli eventi di ques’estate e si riferisce a questa micro-esperienza chiamata ormai Partinico Solidale, scivendo: “Vogliono ripulire una piazza e mettere una giostra per bambini, basterà?”
Mentre scrivo riesco a malapena a contenere l’enfasi, perché ci sono dentro fino al collo e non mi è semplice comprendere, analizzare se e quanto questo percorso possa definirsi una risposta adeguata a tanta violenza. Intanto al momento non siamo soli ad avere scoperto che non esistono posti dove non si può cambiare, non esistono posti dove l’agire individuale non possa farsi collettivo al punto da incidere visibilmente. E se dovessimo dar ragione a chi crede nella specialità negativa di Partinico, possiamo dire che se a Partinico si può, dovunque si può!