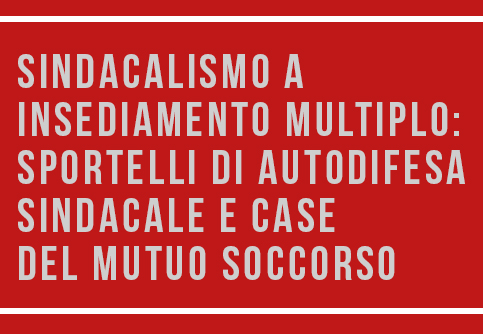Cura collettiva e fare sindacato per cambiare il welfare #1
Il 23 e 24 aprile scorso a Napoli all'ex Asilo Filangeri si è tenuta una formazione sindacale promossa da Fuorimercato dal titolo "Cura collettiva e fare sindacato per cambiare il welfare" Iniziamo la pubblicazione delle relazioni tenute durante la I sessione "La crisi del welfare" con il contributo di Roberta Moscarelli dal titolo "Scuola e cura collettiva nella pandemia" Traccia I sessione: "Scuola, educazione, salute, cura alla persona: qual è lo stato delle politiche di welfare oggi? A che condizioni si accede ai servizi e in che condizioni si lavora in questi settori? Dopo due anni di pandemia e decenni di privatizzazione, quali prospettive di cambiamento strutturale? Ritorno al pubblico statale o welfare mutualistico dal basso?"
Questo contributo si intreccia con altri momenti di riflessione e di mobilitazione sul ruolo della scuola e sulla necessità di interconnettere dal basso vari ambiti e aspetti del welfare che oggi è tanto frammentato e impoverito.
Proprio l’ex Asilo Filangeri un anno fa ha ospitato un momento di approfondimento organizzato dalla nostra Rete Scuola Saperi e Cura (RSSC), con Ernesto Burgio ed Enzo Ferrara, dal titolo Dentro la Pan-sindemia, in cui presentavamo il dossier tematico della rivista Gli Asini su “Salute e democrazia” in un’ottica globale: anche allora, per noi era importante interrogarci su che cos’è oggi la salute e come si lega con la crisi ecologica e climatica, e con i diversi tipi di welfare o di quello che ne rimane non solo in Italia, ma in altri luoghi del mondo. Come RSSC abbiamo in effetti fin dall’inizio cercato di legare mobilitazioni e vertenze a momenti di riflessione e approfondimento, sul nodo salute pubblica e pandemia. Abbiamo, però, scontato un’enorme difficoltà a favorire un legame diretto tra la questione salute e i concretissimi problemi della scuola in pandemia, le chiusure indiscriminate, l’imposizione della Dad come presunta soluzione.
Come RSSC a Napoli e, a livello nazionale, come Priorità alla Scuola, abbiamo fin dall’inizio cercato di disertare la contrapposizione artificiale tra diritto alla salute e diritto allo studio, l’istigazione alla guerra tra poveri, la polarizzazione in cui hanno tentato di tirarci dentro: abbiamo sempre ribadito che questi diritti, peraltro sanciti dalla Costituzione, andavano congiuntamente difesi e rivendicati con ogni mezzo, che non bisognava ritirarsi dallo spazio pubblico della scuola, perché rappresenta tuttora e nonostante tutto una concreta possibilità di emancipazione, di partecipazione e anche di salute e cura per tuttə su tutto il territorio nazionale. Abbiamo cercato di attraversare e interrogare la complessità, smarcandoci, spesso con fatica, dai discorsi banalizzanti e duali tipici di certi meccanismi mediatici e “social” che abbiamo tuttə imparato a conoscere nelle varie fasi di questa lunga emergenza sanitaria e oggi ancora di più in tempo di propaganda di guerra. In primis, la ricerca del nemico interno: sono stati di volta in volta e a seconda della convenienza, colpiti gli (o meglio, le) insegnanti fannullonə e/o irrazionalmente paurosə, gli studentə ancor più fannullonə e/o paurosə e/o immaturə, i genitori (o meglio, le mamme) che avevano bisogno di “parcheggiare” i figli a scuola per passare il tempo al bar nonostante il Covid. Si è trattato di campagne comunicative violente, senza alcun collegamento con la realtà fattuale, ma capaci di incidere pesantemente, purtroppo, sulla nostra (in)capacità collettiva a livello di opinione pubblica e dei movimenti sociali di leggere e riconnettere lotte che a livello settoriale sono state anche molto significative.
Ad ogni modo, noi ci abbiamo provato e ci stiamo ancora provando: per noi è stato importante ragionare collettivamente di salute, prevenzione e cura in pandemia: dei determinanti sociali e ambientali della salute; della salute come un campo che è l’opposto di una questione privata e privatizzabile, che non può riguardare solo il (privilegio e/o la libertà del) singolo cittadino; della salute in quanto campo non riducibile a questione meramente sanitaria, ma includente la dimensione delle relazioni con gli altrə, del benessere psicologico e della salute mentale; della cura intesa come consapevolezza, responsabilità collettiva, rispetto e ascolto delle differenze e delle fragilità, prevenzione e non solo intervento riparativo. Insomma, abbiamo provato faticosamente a tenere insieme aspetti che non sono più immediatamente percepiti come collegati, a causa di questa depoliticizzazione del welfare che ha portato a mettere al centro non più i diritti ma solo bisogni. E i bisogni possono presentarsi tra loro in contraddizione, e rappresentare in questo modo un alibi per continuare a navigare a vista, senza prefigurare e rivendicare politiche e interventi strutturali. Rispetto alla scuola, siamo stati costretti a muoverci in un contesto caratterizzato dall’istigazione dall’alto al conflitto tra bisogni concreti e legittimi, come ad esempio tra chi aveva bisogno che la scuola restasse aperta in qualunque condizione pur di poter continuare a lavorare (in assenza di altre misure di sostegno al lavoro di cura familiare), e chi, come lavoratori o alunnə (o genitori) fragili della scuola, rivendicava la DaD per tutelare la propria salute (in assenza di altre misure concrete di prevenzione, fatta eccezione per il vaccino). Il problema è stato, ed è ancora, come difendere lo spazio dei i diritti, e come allargarlo anche oltre il diritto e la cittadinanza formale, senza però negare l’esistenza e il peso di bisogni sociali anche quando sembrano in contraddizione tra loro, inaspettati ed emergenti, o più urgenti o evidenti in pandemia e nella crisi economica, sociale e politica che stiamo vivendo.
Come intercettare questi bisogni, anche quando si presentano in forme contraddittorie, spurie, anche respingenti, come leggerli e come integrarli nelle battaglie per l’estensione dei diritti sociali? Come sviluppare delle forme di mutualismo dal basso che siano finalizzate a un’accumulazione di potenza, di saperi di parte o, come si diceva un tempo, di costruzione di contropotere. Pratiche di mutualismo dal basso, dunque, non per supplire alle mancanze del welfare statale/istituzionale, non per deresponsabilizzare il governo e le istituzioni della democrazia formale, quanto piuttosto per impattare dentro e contro il campo istituzionale in una prospettiva di trasformazione radicale? Finora non ci siamo certo riusciti, ma ci sono stati molte intuizioni e tracce in che andavano in questa direzione durante questi due anni di pandemia, e molte proprio intorno alla scuola. Priorità alla scuola ne rappresenta l’esempio più significativo, ma in generale si è sviluppato un dibattito ricco sul ruolo e la funzione della scuola. Ad esempio nell’incontro che si è tenuto questa primavera a Bari, si è ripreso il numero monografico di Jacobin Italia del dicembre 2020 intitolato “A che cosa serve la scuola?”, il cui editoriale – purtroppo – è tuttora incredibilmente attuale. È stato immediatamente chiaro a molti, infatti, come la pandemia abbia agito da evento rivelatore delle preesistenti e persistenti mancanze del sistema scuola, che arriva all’appuntamento con l’emergenza sanitaria già impoverito, svuotato e fragile, a causa di decenni di controriforme e definanziamento, in grave carenza di personale, di spazi e risorse. È la scuola che si regge sul lavoro dei precari, del depauperamento culturale e dell’ideologia neoliberista, la scuola dell’Invalsi, della valutazione individualizzata e punitiva, della competizione e della certificazione delle diseguaglianze. Una scuola niente affatto attrezzata per poter reggere l’impatto con una pandemia, e che produceva già prima molto malessere (alcuni studi hanno evidenziato ad esempio che i livelli di ansia prodotti dalle valutazioni scolastiche tra gli studentə italianə sembravano essere molto più alti rispetto ad altri paesi nel mondo, ben prima della pandemia).
Nel governo dell’emergenza, la scuola è stata vista come un settore improduttivo e dunque facilmente sacrificabile. Nel primo lockdown è stato chiuso tutto in tutto il Paese, scuole in primis, ma le fabbriche sono rimaste aperte, contro ogni evidenza e buonsenso, nei distretti produttivi lombardi epicentro della diffusione del Covid-19. Chiudere le scuole ha significato però produrre un imprevisto shock e un’improvvisa presa di coscienza collettiva di quanto sia invece, nonostante tutto, essenziale e prioritaria nella società, ha evidenziato quanto ci sia bisogno di scuola e quanto conti il diritto allo studio, e ha comportato la nascita di tante mobilitazioni locali e di un movimento nazionale come Priorità alla Scuola. Nelle aree più fragili del paese, nelle periferie, al sud, la scuola è stata chiusa più che altrove (come in Campania e in Puglia), è stata chiusa dunque proprio dove ce n’era più bisogno, in quanto unico spazio istituzionale riconosciuto come risorsa pubblica in territori in cui dallo Stato ci si aspetta solo abbandono e repressione. La battaglia per la scuola in presenza è stata l’occasione per rilanciare la mobilitazione complessiva sulla scuola, e anche a vincere alcune importanti battaglie. Tuttavia, il governo non ha tenuto conto delle nostre richieste sugli interventi strutturali. L’unico intervento sulla messa in sicurezza è stato quello sulle forniture dei famosi banchi a rotelle, mentre non si è investito né in spazi né soprattutto nella stabilizzazione di personale aggiuntivo docente e non docente, necessario per garantire la didattica in gruppi più piccoli. Si aspetta la denatalità per risolvere il problema delle classi pollaio, è stato esplicitamente ammesso quando era ancora ministro Azzolina, e naturalmente la linea non cambia con Bianchi, anzi. Nel frattempo si sfrutta il lavoro dei precari per tappare i buchi, e il concorso a cattedra ordinario e straordinario attualmente in corso è una farsa: era importante formalmente dimostrare di averlo fatto dopo tanti anni di attesa, ma anche far fuori la stragrande maggioranza dei candidati, per poter continuare a risparmiare sulla spesa per l’istruzione grazie al precariato eletto a sistema, sistema “conveniente” ma che non solo è ingiusto, ma anche inefficiente, come abbiamo drammaticamente visto in pandemia. La scuola italiana fa un più largo uso del lavoro precario ad altri paesi, dove pure si taglia sull’istruzione, ma in Italia su questo abbiamo il primato. Qui alla scuola si è pensato di poter rinunciare perché il lavoro di cura viene demandato alle famiglie ovvero alle donne, perché il lavoro delle donne è considerato accessorio, soprattutto al sud. Al nord, d’altro canto, alla scuola è stata riconosciuta una funzione di servizio ancillare rispetto alla continuità del lavoro in presenza dei genitori: erano aperti i distretti produttivi, dunque anche la scuola doveva esserlo. Questo è stato evidente soprattutto nella seconda fase della pandemia, quando è cambiata la gestione dell’emergenza (anche grazie alla disponibilità dei vaccini). Per esigenze principalmente economiche, la scuola è tornata in presenza, sebbene ancor più invivibile e patogena, visto che non è stato ritenuto prioritario dare spazio alle necessità di elaborazione di un trauma collettivo o recuperare le dimensioni relazionali e di apprendimento sacrificate nell’emergenza, ma anzi al contrario, si è scelto di perseverare con pervicacia nell’esaltazione della centralità di meccanismi valutativi individualizzanti, meritocratici ovvero di certificazione delle diseguaglianze socio-economiche, che non sono stati mai messi in discussione, neanche nel primo anno scolastico vissuto in pandemia.
Nell’ambito di Priorità alla Scuola abbiamo lavorato in particolare su questi temi attraverso il Tavolo salute pubblica e scuola (di cui faccio parte), e il Tavolo pedagogia e valutazione, pur senza interlocuzioni possibili con il governo, che invece vuole oggi ulteriormente a modificare unilateralmente addirittura il contratto collettivo dei docenti, legando non solo il reclutamento, ma anche gli scatti stipendiali alla valutazione di merito dei singoli docenti, relativamente alla loro “libera” partecipazione a corsi di formazione sempre più scollegati dalla realtà e dalla didattica, che saranno gestiti da un ennesimo costosissimo carrozzone tipo Invalsi. Insomma nessun cambiamento di rotta del governo rispetto alle nostre rivendicazioni di investimenti strutturali, per ottenere soprattutto più docenti stabilizzati e spazi più ampi (e più umani) per la didattica. Non è stata data alcuna risposta a bisogni, intuizioni e possibili soluzioni importanti emersi durante la pandemia, ad esempio e banalmente, poter fare lezione all’aperto, qualcosa che sarebbe stato se non altro ragionevole con una pandemia da virus che si trasmette per via aerea.
La scuola per come è, insomma, non l’abbiamo mai rimpianta, abbiamo cercato di metterla in discussione e in critica, con molte difficoltà anche per i limiti dei sindacati nella scuola, compreso il sindacalismo di base. I Cobas Scuola peraltro hanno dato un contributo importante in questi due anni anche nel movimento di PaS.
Perché la scuola è collegata alla salute? Intanto, perché il sacrificio della scuola è stato possibile nel quadro della stessa svalutazione del welfare che prevede la riduzione della salute a questione privata, alla stessa ideologia che punta a un modello riparativo, ospedale-centrico e farmaco-centrico, disinteressato alle dimensioni sociali della salute e della malattia e alla prevenzione. È incredibile che siano riusciti a far passare questo proprio durante una pandemia, che si caratterizza per la sua dimensione globale e collettiva. Nei primi mesi della pandemia in realtà in tutti i territori c’è stato un fortissimo attivismo delle reti autorganizzate di solidarietà dal basso, di iniziative di mutuo-aiuto che hanno offerto sostegno economico, alimentare, educativo, ed anche direttamente di prevenzione e cura, perché l’opinione pubblica sapeva, sentiva, intuiva in modo immediato la dimensione sociale dell’emergenza. Non c’era alternativa accettabile rispetto al salvarsi insieme. Nel mondo della scuola, questa tensione a non abbandonare i più fragili, a tenere unite le classi e le comunità, ha portato nella prima metà del 2020 a forme spontanee di impegno e alla sperimentazione di nuove modalità didattiche e comunicative da parte di moltissimi docenti, anche attraverso un uso autogestito e solidale della dad che a mio avviso ha avuto un valore importante e andrebbe meglio documentato e problematizzato. Poi è arrivata l’istituzionalizzazione, la sussunzione di questa modalità da parte del governo, insieme a silenziamento, delegittimazione e riduzione delle esperienze dal basso più radicali al campo della cura come sacrificio personale, e la virata verso un modello riduttivo e burocratizzato.
Anche l’allarme sul diffuso malessere psicologico degli adolescenti - tra i soggetti più colpiti da campagne di vera e propria criminalizzazione durante la pandemia, in quanto improduttivi, “untori”, a malapena tollerati come consumatori-, è stato oggetto di speculazioni da parte di alcune lobby della psichiatria tra pubblico e privato che hanno colto l’occasione per chiedere più posti letto per terapie psichiatriche invasive, o per puntare sull’erogazione del bonus psicologo. Non è stata mai in predicato alcuna reale presa in carico di un malessere psicologico tanto diffuso e profondo. È chiaro che è proprio questo modello di scuola, di welfare e di società che è in sé patogeno in quanto antisociale, ed è naturale che i soggetti più sensibili come i bambini e gli adolescenti lo capiscano per primi e ne risentano in modo particolare, tanto più durante una pandemia e tanto più ora, con la guerra alle porte dell’Europa.
Abbiamo dunque una scuola che certifica le disuguaglianze e che sentiamo la necessità di trasformare in modo radicale. Che fare? Prima di tutto, come abbiamo nel nostro piccolo sempre cercato di praticare, ascoltare con attenzione gli studenti e confrontarsi con le loro rivendicazioni evitando atteggiamenti anche inconsapevolmente paternalistici. Qui a Napoli ad esempio, dove abbiamo avuto la scuola chiusa più a lungo che altrove, l’anno scorso quando ancora non erano disponibili i vaccini si è prodotta una frattura nell’opinione pubblica e anche nel movimento quando i collettivi riuniti nell’Osservatorio Popolare Studentesco hanno occupato le scuole rivendicando non la semplice riapertura, ma tamponi gratis per tutti, e una reale messa in sicurezza degli edifici e degli spazi scolastici, interventi concreti sui trasporti e sui numeri degli studenti per classe: non si accontentavano del “metro tra le rime buccali” o dei banchi a rotelle, insomma, hanno occupato chiedendo interventi strutturali. Per questo sono stati criticati come fannulloni, ricevendo dal mondo adulto scherno e ammonimenti sul fatto che avrebbero dovuto accontentarsi di tornare a scuola in presenza (e gravi sanzioni disciplinari dalle dirigenze scolastiche: alcuni hanno rischiato di non essere ammessi all’esame di maturità), mentre hanno ottenuto solidarietà e ascolto solo da pochi soggetti (tra cui la Rete Scuola Saperi e Cura). La stessa cosa è successa agli stessi studenti quando hanno criticato il ritorno all’esame di stato “serio”, le intoccabili prove Invalsi e la raffica di verifiche e valutazioni sommative a cui si è purtroppo spesso ridotto il tanto desiderato ritorno in presenza negli ultimi mesi dello scorso anno scolastico. Gli studenti in quella fase hanno trovato pochi alleati, anzi sono stati accusati di non aver voglia di studiare né di prepararsi al mondo del lavoro, mentre erano forse gli unici che ancora tentavano di cogliere l’opportunità di non tornare alla normalità ma di mettere in discussione tutto. Quest’anno invece il movimento studentesco è riuscito a riversarsi in modo potente nelle piazze in Italia, soprattutto, purtroppo in occasione della tragica morte di due giovanissimi per infortuni durante l’alternanza scuola lavoro. Questo modello di scuola, dobbiamo avere il coraggio di ribadirlo con chiarezza, mette in conto di ferire e uccidere non solo a livello psicologico o simbolico, ma purtroppo anche in modo molto concreto e materiale. Ed è qualcosa che colpisce e che deve interrogarci, che un movimento studentesco metta al primo posto delle sue rivendicazioni l’urgenza di un intervento strutturale per garantire la cura e il benessere psicologico nella scuola (e attraverso la scuola) a tutte e tutti. Sul come rispondere a questa esigenza e su che proporre in concreto dobbiamo ragionarci insieme. Come tavolo Salute pubblica e scuola abbiamo cominciato a farlo, chiedendoci quale potrebbe essere un approccio efficace, sostenibile e democratico. Chiedere uno sportello psicologico per ogni scuola, come diverse realtà studentesche fanno, è la strada adeguata? Garantire un percorso psicologico individuale sarebbe una soluzione efficace (ove mai fosse praticabile, data l’enormità della richiesta da parte degli adolescenti)? Oppure questa delega ad esperti del benessere psicologico individuale sarebbe una soluzione tampone, di tipo correttivo, “ortopedico”, orientata all’addestramento di singoli giovanissimi ad adattarsi un sistema malato? E se invece si facesse da sé, imparando a prendersi reciprocamente cura degli altri in gruppi di auto-mutuo-aiuto? Non sarebbe “scuola” anche o soprattutto questa? Forse la strada è nel mezzo, cioè provare a costruire dei saperi di parte, studiando, sperimentando, confrontandosi con chi ha più esperienza, costruendo pratiche nuove, partendo dalla consapevolezza, che nessuno può più toglierci, che la salute è un diritto e un bene collettivo di cui prenderci cura insieme.