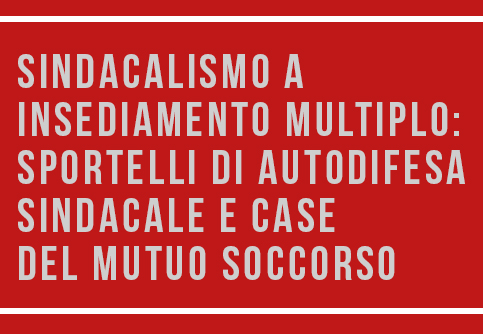La lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro bracciantile in agricoltura sembra a una svolta. Ma è difficile capire verso quale direzione. Da un lato, il governo nazionale e alcune delle regioni interessate almeno dal 2014 hanno posto maggiore attenzione a queste problematiche e varato un gran numero di task force, disegni di legge, protocolli.
di Mimmo Perrotta (pubblicato sulla rivista Lo straniero, n. 196, ottobre 2016)
La lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro bracciantile in agricoltura sembra a una svolta. Ma è difficile capire verso quale direzione. Da un lato, il governo nazionale e alcune delle regioni interessate almeno dal 2014 hanno posto maggiore attenzione a queste problematiche e varato un gran numero di task force, disegni di legge, protocolli. Dall’altro lato, i braccianti stranieri, con il supporto di associazioni, sindacati, collettivi, hanno manifestato numerose volte a Foggia, Bari, Venosa, Potenza, Latina, Rosarno. In entrambi i casi, gli obiettivi dichiarati sono la lotta allo sfruttamento e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti; tuttavia, l’interlocuzione tra le due parti – tra un nascente movimento di braccianti e le istituzioni – è particolarmente difficile. Perché?
Una risposta sta a mio parere nel fatto che le istituzioni pubbliche non riconoscono i braccianti migranti come interlocutori privilegiati nella lotta allo sfruttamento e al caporalato. Un paradosso: come combattere gli sfruttatori senza coinvolgere gli sfruttati nella lotta? Paradosso forse solo apparente,chenasconde altri obiettivi, altri interessi.
Provo ad argomentare, guardando a entrambi i fronti.
Negli ultimi anni, governo ed enti locali hanno rappresentato il problema del lavoro agricolo come una questione umanitaria: come hanno già scritto su Gli Asini Enrica Rigo e Nick Dines (“Braccianti stranieri e retorica umanitaria”, n. 25, gennaio-febbraio 2015),i lavoratori migranti sono rappresentati come “vittime” – di violenze, schiavitù, tratta, mafia, ecc. – e non come lavoratori sfruttati in un sistema economico basato, come è ovvio, sul profitto.
Di qui, due tipi di provvedimenti.Da un lato,leggi che operano in direzione di una repressione penale del caporalato: di questo tipo è il disegno di legge “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, approvato in Senato in agosto e ora in discussione alla Camera. Il disegno di legge modifica l’articolo del codice penale sul reato di caporalato (istituito nel 2011) eprevede sconti di pena per i pentiti, la confisca dei prodotti o dei profitti del reato, il sequestro o il controllo giudiziario delle aziende,l’arresto in flagranza, l’estensione del fondo per le vittime di tratta anche alle vittime di caporalato. Qual è qui il problema? Non certo che il caporalato non sia una pratica odiosa da punire. Ma, come hanno notato alcuni giuristi e penalisti (inLeggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura, a cura di Enrica Rigo, Pasini, 2015), la repressione penale non è lo strumento più adatto alla lotta all’intermediazione illecita di manodopera, né tantomeno allo sfruttamento del lavoro.Il caporalato è fenomeno quotidiano, soprattutto in alcune colture, prima tra tutte il pomodoro da industria nel foggiano; i caporali che operano nel Sud Italia sono centinaia e in molte aree sono indispensabili alla produzione agricola. Il diritto penale, scrivono i giuristi, dovrebbe colpire casi eccezionali, non pratiche quotidiane; forze dell’ordine e magistrati sarebbero obbligati a impegnarsi in indagini, raccolta di prove, processi (dall’esito molto dubbio) per arrestare e incarcerare centinaia di mediatori di manodopera, sequestrare milioni di tonnellate di ortaggi e frutta (è possibile stimare che almeno la metà dei due milioni di tonnellate di pomodori da industria prodotti nel Mezzogiorno siano raccolti da braccianti reclutati e trasportati da caporali). Meglio sarebbe, quindi, intervenire con altri strumenti normativi (ad esempio, di diritto del lavoro) direttamente nell’organizzazione del mercato del lavoro e del settore agricolo.
Dall’altro lato, vi sono politiche di tipo soprattutto emergenziale-umanitario: tendopoli, centri di accoglienza affidati alla Croce Rossa o alla Protezione Civile, come è accaduto negli interventi della Regione Puglia nel 2014, della Regione Basilicata tra 2014 e 2016 e della Regione Calabria dopo la rivolta di Rosarno del 2010. In nessun caso questi enti hanno attuato progetti per l’accoglienza abitativa dei lavoratori agricoli stagionali che tenessero conto del fatto che non di emergenza si tratta, ma di un fenomeno che si ripete tutti gli anni, per il quale servono quindi politiche per la casa di tipo strutturale. Anche in questi casi, i lavoratori agricoli sono trattati come vittime, da soccorrere con interventi emergenziali, come se si trattasse di un terremoto.
Va qui notato che i migranti sono in primo luogo soggetti a normative sull’immigrazione che li rendono particolarmente deboli di fronte a datori di lavoro e caporali: sono note le difficoltà di ottenere e mantenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di ottenere la residenza per chi si sposta di regione in regione seguendo le raccolte stagionali, di obbligare i datori di lavoro al versamento del numero di giornate di lavoro necessario al rinnovo del permesso; sono note le difficili situazioni dei richiedenti asilo e di quanti possiedono un permesso di soggiorno “umanitario”, che non possono spostarsi in altri paesi europei. Altro paradosso, quindi: stati ed enti locali soccorrono con interventi umanitari delle persone che altre leggi dello stesso stato hanno contribuito a rendere vulnerabili. Per migliorare la vita di molti braccianti migranti basterebbe piuttosto modificare le normative sull’immigrazione, rendendo più libera la mobilità, più semplice ottenere una residenza, un domicilio, un permesso di soggiorno.
(Per inciso: questa rappresentazione vittimizzante è sostenuta anche dai ricorrenti articoli sugli “schiavi” di Foggia, di Rosarno, ecc., tanto sui principali quotidiani quanto su vari blog più o meno benintenzionati. Come esempio recente di questo tipo di giornalismo “di denuncia” – superficiale e per lo più dannoso alla causa dei braccianti – si veda l’articolo di Fabrizio Gatti sull’Espresso del 21 agosto 2016, che denuncia violenze islamiste tra i braccianti del “Grand ghetto” vicino Foggia, subito smentito dalla Caritas foggiana. Come esempio di un giornalismo ben diverso, si leggano gli articoli sui braccianti migranti in California pubblicati nel 1936 da John Steinbeck sul San Francisco News, tradotti in italiano nel volume I nomadi, Il Saggiatore, 2015).
Di tipo parzialmente diverso sono l’articolo 8 del disegno di legge citato sopra, dedicato alla “Rete del lavoro agricolo di qualità”, e il “Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Cura – Legalità – Uscita dal ghetto”, firmato il 27 maggio scorso a Roma dai ministeri del Lavoro, dell’Interno e delle Politiche Agricole, da cinque regioni, dai sindacati confederali, dalle organizzazioni datoriali e da soggetti del terzo settore. Quivi sono segnali nuovi e potenzialmente positivi in direzione di politiche “attive” nei confronti dei braccianti:servizi di trasporto dei lavoratori agricoli da e verso i luoghi di lavoro (e relativi contributi); “modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale”; “forme di intervento pubblico/privato nel collocamento della manodopera”; “sperimentazione di sportelli di informazione per l’incontro domanda e offerta di servizi abitativi”. Siragiona quindi di quelle politiche che potrebbero davvero rafforzare i braccianti e indebolire caporali e datori di lavoro: una casa, un autobus per andare a lavoro, un servizio di collocamento che dia ai braccianti un’alternativa ai caporali nella ricerca dell’impiego.
Mi pare però che vi siano ancora numerosi problemi. In primo luogo, non è chiaro chi sia il soggetto di queste politiche, chi debba attuare questi provvedimenti: il disegno di legge si riferisce alla “Rete del lavoro agricolo di qualità” (istituita nell’agosto 2014, con obiettivi e compiti piuttosto fumosi), alla sua “cabina di regia” e alle sue costituende “sezioni territoriali”; il protocollo dispone invece l’attivazione sul territorio di “tavoli permanenti di coordinamento presieduti dal Prefetto della singola realtà territoriale”. La Rete del lavoro agricolo di qualità farà dunque capo alle prefetture?
In secondo luogo, né il Disegno di legge né il protocollo prevedono il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori interessati da queste politiche. Siamo qui nel cuore del problema: ministri e presidenti di regione pretendono di combattere gli sfruttatori senza gli sfruttati.
Dove porti questo approccio lo si può vedere analizzando quanto è accaduto negli ultimi tre anni in Basilicata – per molti versi un laboratorio di queste politiche –, in particolare nei comuni di Venosa e Palazzo San Gervasio. Qui, come è noto, da anni almeno mille braccianti subsahariani danno vita nei mesi di agosto-ottobre ai due “ghetti” di Boreano e Molini-Matinelle e i caporali monopolizzano intermediazione e trasporto per la raccolta del pomodoro da industria. Dal 2014 la Regioneha varato una serie di azioni, tra cui due centri di accoglienza e liste di prenotazione dei braccianti nei centri per l’impiego, fino allo sgombero forzato del ghetto di Boreano il 28 luglio 2016. Tuttavia, la raccolta del pomodoro 2016 si sta svolgendo in condizioni non dissimili da quelle degli anni scorsi (a parte un certo nervosismo dei braccianti, dovutoallo sgombero del ghetto e alla bassa qualità del pomodoro nei campi, che rende più bassi i loro salari a cottimo). Solo una piccola parte dei braccianti ha accettato in questi anni l’ospitalità dei centri, sia perché considerati poco accoglienti, sia perché i caporali preferiscono non recarvisi per reclutare gli operai;i braccianti guadagnerebbero quindi un alloggio e perderebbero l’impiego. Infatti, nonostante la registrazione di centinaia di braccianti nelle liste di prenotazione, la gestione dell’intermediazione e dei trasporti è ancora monopolizzata dai caporali. Il servizio di trasporto pubblico dei braccianti da e verso i luoghi di lavoro non è stato ancora attivato, dopo tre anni. Lo sgombero forzato del ghetto di Boreano ha costretto i braccianti a occupare altri casolari abbandonati a qualche km di distanza, non ha incrinato il rapporto tra braccianti e caporali e, semmai, l’ha reso più forte.
Cosa insegna questa esperienza? Politiche che potrebbero andare nella direzione giusta – accoglienza, servizi di collocamento – non hanno di fatto migliorato le condizioni di vita e di lavoro dei braccianti migranti, perché sono state concepite e attivate senza i braccianti. Altre – i trasporti – non sono partite perché di fatto non possono essere attuate senza il coinvolgimento diretto dei lavoratori. Se è sacrosanto che i braccianti non vivano in baracche ecasolari abbandonati, questo risultato non può essere raggiunto con gli sgomberi coatti – senza peraltro attivare strutture di accoglienza dignitose – ma con la costruzione di rapporti di fiducia con i lavoratori stagionali.
È facile sospettare che trattare i braccianti come vittime da soccorrere e non come lavoratori sfruttati con cui discutere abbia come effetto (o come obiettivo?) quello di rimandare il più possibile il miglioramento delle loro condizioni. È facile sospettare che, più che i braccianti, gli interlocutori privilegiati di alcuni ministeri e di alcune amministrazioni regionali siano i datori di lavoro (ai quali non si è mai riusciti a imporre di aderire realmente ad alcun protocollo) e le organizzazioni a cui viene appaltata – a cifre rilevanti – la gestione di tendopoli e centri di accoglienza. In altre parole, il dispositivo della vittima consente a ministri e presidenti di regione (ma anche rappresentanti di catene di supermercati) di conciliare roboanti dichiarazioni contro caporali e ghetti (“una vergogna da cancellare”) con un atteggiamento accondiscendenteverso le imprese agricole (e verso il “made in Italy”), nello stesso tempo delegittimando quanti provano a organizzare i lavoratori.
E che qualcuno, nei ministeri, pensi ai lavoratori solo in termini strumentali lo rivelano alcune espressioni del disegno di legge approvato al Senato: vi si parla infatti non di accoglienza abitativa, ma di “misure per la sistemazione logistica” dei lavoratori, come se fossero delle merci.
Certo, si dirà, è difficile per le istituzioni trovare degli interlocutori tra i lavoratori stagionali migranti, che non hanno forme di rappresentanza stabili. Questo è in parte vero. Ma è altrettanto vero che negli ultimi anni il movimento dei braccianti ha fatto numerosi passi in avanti e i braccianti stessi hanno più volte sollecitato le istituzioni a incontri e tavoli tecnici.
Sono almeno quattro gli “epicentri” di questo movimento bracciantile. Uno è proprio la Basilicata, a partire dai braccianti africani di Boreano, che hanno manifestato il 3 ottobre 2013 a Potenza (con le associazioni Fuori dal ghetto e Osservatorio Migranti Basilicata) e poi numerose volte nel 2016, supportati dall’Unione sindacale di base, che da un anno prova a fare attività sindacale nelle campagne lucane: il 5 maggio a Venosa, il 12 maggio a Potenza, il 28 giugno con una “marcia della dignità e dei diritti” da Boreano a Venosa, il 4 agosto a Potenza, dopo lo sgombero del ghetto.
L’altro epicentro, a meno di 100km di distanza, è Foggia.Qui la rete Campagne in lotta e, più recentemente, un altro sindacato di base, il Sindacato Intercategoriale Cobas (attivo nelle lotte dei facchini della logistica nella Pianura Padana), e alcune associazioni pugliesi, hanno sostenuto i braccianti agricoli in numerose manifestazioni a Foggia (2 settembre 2013, 26 settembre 2014, 4 e 30 settembre e 4 dicembre 2015, 29 febbraio 2016) e a Bari (30 giugno 2016). Il momento di lotta più alto è stato qui il blocco di due conservifici – la multinazionale Princes, uno degli stabilimenti più grandi d’Europa, e la Futuragri – messo in atto il 25 agosto scorso nei pressi di Foggia: centinaia di braccianti hanno impedito fisicamente l’accesso alle due industrie per ore, bloccando decine di camion carichi di pomodori e causando un ingente danno economico alla filiera. Una forma di lotta senza precedenti in Capitanata, molto simile ai blocchi dei magazzini della logistica attuati dai SI Cobas in Emilia, Veneto e Lombardia.
Altro epicentro del movimento è la Piana di Gioia Tauro, in Calabria; qui, il 9 e il 30 giugno scorsi vi sono state due manifestazioni di protesta dopo l’uccisione di un cittadino maliano, Sekine Traoré, da parte di un carabiniere nella tendopoli di San Ferdinando, in circostanze ancora non del tutto chiarite.

Le rivendicazioni dei braccianti di Foggia e di Venosa sono simili e riguardano sia i permessi di soggiorno sia salari e condizioni di lavoro. In entrambi i casi, i braccianti e le organizzazioni che li sostengono hanno incontrato prefetti, sindaci e rappresentanti regionali in diverse occasioni, hanno ottenuto impegni a convocare tavoli, talvolta hanno strappato vittorie importanti (ad esempio, il Comune di Venosa – incalzato dall’Usb – ha finalmente concesso la possibilità ai braccianti stagionali di ottenere la residenza fittizia a Venosa, fondamentale per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno).Tuttavia, nei momenti in cui vengono elaborate le politiche e firmati i protocolli, i braccianti e le loro organizzazioni raramente vengono consultati. Gli unici sindacati che sostengono questi protocolli sono le categorie dell’agroindustria dei sindacati confederali (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil), i quali, però, non discutono di tali provvedimenti con i braccianti nei ghetti foggiani e lucani.
Il quarto epicentro del movimento bracciantile è l’Agro Pontino, dove invece è proprio la Flai-Cgil,con l’associazione InMigrazione, ad aver organizzato una importante manifestazione con 2000 braccianti, in gran parte di nazionalità indiana e di religione sikh, a Latina il 18 aprile 2016. Le rivendicazioni riguardavano qui condizioni di lavoro e salari, ma non i permessi di soggiorno.
Si può parlare di un movimento bracciantile, a cinque anni dallo sciopero dei braccianti di Nardò? Forse sì. Si tratta però di un movimento che ha ancora numerose questioni da affrontare e da risolvere.
La più evidente è la frammentazione: vi sono a oggi pochissimi contatti e scambi tra le organizzazioni di questo movimento: non solo tra la Flai-Cgil (di Latina e di altre province) e i sindacati di base attivi a Foggia e Venosa, ma anche tra questi ultimi. Un bracciante burkinabé molto attivo in Basilicata ha parlato ironicamente di “tendenza alla gruppettizzazione” da parte dei militanti italiani.
La seconda riguarda la continuità: i braccianti più attivi e più capaci molto spesso preferiscono, ove possibile, cercare un impiego migliore in altre regioni d’Italia e in altri settorieconomici, piuttosto che restare nei ghetti; questo impoverisce costantemente i movimenti.
Infine, vi è la questione delle rivendicazioni e delle prospettive di lotta: quali vittorie riuscirà a strappare nel breve periodo questo movimento? E quale agricoltura viene prefigurata nelle richieste dei braccianti?La questione è complicata, perché non pochi osservatori ritengono che l’agricoltura industriale contemporanea – dominata dalle catene della grande distribuzione – difficilmente possa sostenere un lavoro non sfruttato, senza un cambiamento strutturale. Per non fare che due esempi: nel caso in cui i raccoglitori di pomodoro della Capitanata e della Basilicata ottenessero davvero salari più alti, è probabile che gli agricoltori preferirebbero meccanizzare completamente la raccolta, utilizzando quindi pochissimi operai, e questo causerebbe poi la chiusura delle piccole aziende agricole ancora attive e una concentrazione della coltivazione in un numero minore di grandi aziende capaci di sostenere i costi della meccanizzazione; oppure, a Rosarno, gli agrumicoltori semplicemente lascerebbero il prodotto a terra, sostituiti nei supermercati e nelle industrie del succo dalle arance spagnole, sudafricane, brasiliane o maghrebine (si veda la bella ricerca di Anna Mary Garrapa, Braccianti just in time. Raccoglitori stagionali a Rosarno e Valencia, Firenze, La Casa Usher, 2016).Tuttavia, non è impossibile che la mobilitazione dei braccianti possa scompaginare le carte – e le strutture di potere – nelle filiere agroindustriali e ottenere il rispetto dei contratti di lavoro, soprattutto in un momento in cui il settore e le sue esportazioni sono in crescita.
Per completare il quadro dei movimenti bracciantili, va segnalato il numero crescente di lavoratori migranti che entrano come protagonisti attivi in progetti di agricoltura contadina.Oltre a SOS Rosarno, attiva ormai dal 2010,vanno segnalatile associazioni Solidaria di Bari e Diritti a Sud di Nardò (che hanno dato vita a una filiera del pomodoro “Sfrutta Zero”), il progetto Funky Tomato in Basilicata e Campania, il gruppo Contadinazioni in Sicilia occidentale. Queste realtà sperimentano concretamente e tra mille difficoltà e contraddizioni forme di produzione del cibo e di relazioni di lavoro alternative; non si accontentano di occupare piccole nicchie etiche e solidali di produzione e consumo, ma in molti casi cercano di dialogare con (e sostenere, attraverso “casse di resistenza”) le lotte dei braccianti sui loro territori. Inoltre, sono attive in reti nazionali (come la rete “Fuori Mercato”, che coinvolge anche la fabbrica occupata Ri-Maflow di Milano) e, assieme ad altre organizzazioni contadine (come Associazione rurale italiana e Crocevia) e sindacali (l’Usb), in queste settimane preparano la delegazione italiana al secondo forum europeo per la sovranità alimentare, che si terrà a Cluj-Napoca, in Romania, a fine ottobre. Un tema fondamentale, se teniamo conto che la principale preoccupazione degli agricoltori pugliesi e lucani di quest’estate è stata l’abbassarsi costante dei prezzi di grano e uva a causa della concorrenza internazionale.
Da un lato, si fa più forte la pressione dei braccianti sulle aziende che operano nell’agricoltura industriale; dall’altro, organizzazioni piccole ma combattive propongono l’agricoltura contadina (o l’agroecologia) come alternativa di sistema all’agricoltura industriale, anche coinvolgendo lavoratori migranti. Possono dialogare queste due prospettive? È possibile, citando Pino Ferraris, ricucire il rapporto tra organizzazioni della resistenza e organizzazioni del mutualismo? È possibile costruire una nuova agricoltura?
Si ringraziano l’autore e l’editore Goffredo Fofi per l’autorizzazione alla pubblicazione