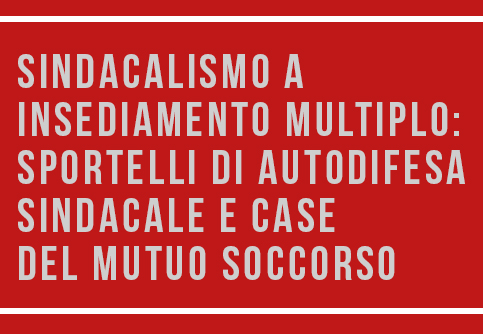L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.
(Italo Calvino – Le città invisibili)
di Piero Maestri
501. Questo il numero delle morti per Covid-19 il 1 aprile 2021 in Italia (e non cambia nulla se nei conteggi ci siano anche quelli di giorni precedenti, magari «spalmati» da qualche funzionario compiacente con le velleità politiche assessorili). Impossibile prescindere da loro. Impossibile prima di tutto perché erano persone, donne e uomini perduti ai loro affetti, morte e morti quasi tutti in isolamento, senza l’abbraccio dei loro cari. Impossibile anche perché la loro morte ci parla – ci chiede di fare tutte e tutti quello che possiamo, e anche qualcosa di più, per evitare che altre e altri debbano morire per questo virus, qui da noi e in tutto il mondo.
Intendiamoci. Nessuno può permettersi di parlare in nome dei morti. Lo fece dieci mesi fa Matteo Renzi secondo il quale «se i morti di Bergamo e Brescia potessero, ci chiederebbero di riaprire»… No, nessuno può chiedere nulla in nome loro. La loro morte può solamente ricordare, ogni giorno, che le scelte politiche ed economiche degli anni passati e di questi mesi hanno una correlazione diretta con questi decessi.
Personalmente rifuggo, soprattutto sui social network, una discussione generale o peggio di principio su «chiusure si, chiusure no». In questo senso il mio pensatore di riferimento è Zerocalcare. Certamente le scelte politiche in merito alle chiusure e aperture – così come quelle che riguardano la sanità pubblica e il piano di vaccinazioni – hanno effetti e conseguenze anche drammatiche sulla vita delle persone. Ciò che non mi sembra particolarmente interessante e nemmeno utile a fare qualche passo avanti è però la discussione basata sulla condanna dell’eresia altrui e sulla mancanza di accettazione di punti di vista differenti (la madre di tutte le scomuniche resta l’etichetta di «avere posizioni confindustriali», che rende ovviamente inascoltabile una posizione considerata sulla base di tale presupposto).
Non sono tra coloro che hanno seguito quotidianamente i numeri, le statistiche, l’evoluzione dei contagi, le diatribe su ricerche contraddittorie tra loro e i tanti studi scientifici che non sempre portano alle stesse conclusioni (cosa di per sé né scandalosa né infrequente – la scienza non è basata su certezze date una volta per tutte, ma sul confronto delle tesi, dei dati, delle conclusioni provvisorie). Insieme ad altri e altre ho provato a stare nelle cose possibili, a partire dalla realtà quotidiana, non per accettarla come inevitabile ma per provare a creare le condizioni per un cambiamento. «Andrà tutto meglio!» non è mai stato il nostro motto, ma non abbiamo mai accettato che fosse necessario che tutto andasse peggio. Parafrasando il titolo del libro di Daniel Tanuro, anche in materia politica e sociale di fronte alla pandemia e alle politiche conseguenti è troppo tardi per essere pessimisti.
Molte delle assemblee, da remoto, di questi mesi partivano da una domanda rivolta a ognuno e ognuna di noi: «Come sto? Come vivo questo periodo?». Una domanda rivolta a ciascuno perché diventasse scambio, racconto, sostegno e cura reciproca. Quelle assemblee sono state molto utili, hanno aiutato a non farci sentire soli e sole, a non chiudere la porta all’altro, a elaborare insieme una condizione difficile. E soprattutto a continuare a pensare e progettare l’azione diretta, a superare la sensazione e l’accettazione di dover vivere un tempo sospeso.
A distanza di un anno dalle prime chiusure è necessaria un’elaborazione collettiva su come pensare il lockdown che ancora stiamo vivendo e soprattutto il dopo lockdown. Abbiamo bisogno di qualcosa di diverso dalle assemblee che partivano dal soggettivo (come stiamo?), per provare ad affrontare la domanda «come sta la società di cui facciamo parte?». Le ricerche e gli studi di questi mesi hanno reso evidente quanto siano aumentate la povertà, la solitudine, il malessere, le difficoltà di relazione sociale. Studi e ricerche che sono la conferma di quanto vediamo quotidianamente nei nostri sportelli sociali.
Mettere continuamente in relazione e a confronto le nostre esperienze sociali e quegli studi e ricerche sarebbe un esercizio necessario e salutare. La nascita della rete per una sociologia trasformativa e di posizione va in questa direzione, partendo dal punto di vista e dal lavoro intellettuale di un gruppo di sociologhe e sociologi che dichiarano di voler usare «gli strumenti della ricerca sociale per disegnare un’altra vita per l’Italia e l’Europa, a cominciare da una nuova idea di cura collettiva, non affidata agli attori della grande finanza, ma restituita ai suoi stessi beneficiari. L’innovazione di cui abbiamo bisogno non è quella predefinita dalle élites tecnocratiche, ma un cambiamento reale fondato sui desideri, i bisogni e gli interessi collettivi degli attori sociali».
Ciò avrebbe anche un altro obiettivo. È una sensazione condivisa da molti e molte l’assenza di una soggettività politica collettiva nella quale riconoscersi, di una discussione aperta e rispettosa sulle scelte urgenti da fare per rispondere a quelle povertà e a quel disagio dentro la crisi pandemica. I social network sono pieni di dichiarazioni di isolamento, di questa assenza di un luogo collettivo. I luoghi collettivi in realtà sono moltissimi e l’attivismo sociale si è moltiplicato in questo anno – pensiamo all’esperienza delle brigate solidali, comunque si siano chiamate. È però vero che non sempre si è riusciti ad andare oltre l’impegno solidale necessario ma insufficiente.
La scorsa settimana Milano – così come altre città – ha visto una forte presenza pubblica di soggettività in lotta, di vertenze sociali, lavorative e politiche che si sono mostrate pubblicamente nelle strade della città. Una settimana iniziata con lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di Amazon e proseguita con lo sciopero dei riders, le mobilitazioni di genitori e insegnanti di Priorità alla scuola e conclusasi con l’occupazione del Piccolo teatro Grassi da parte del Coordinamento lavoratrici e lavoratori dello spettacolo. E nelle settimane precedenti avevamo visto tornare in piazza le e i giovani di Extinction Rebellion e Fridays for Future, e prima ancora la rete di spazi sociali e beni comuni «Milano non si vende» e le donne di Non una di meno in diverse occasioni – dopo che nei mesi scorsi si era palesato un Black lives matter italiano.
Un riflesso pavloviano politicista potrebbe semplicemente concludere che sia ora necessaria una «piattaforma unitaria di lotta», magari una «piattaforma politica» complessiva che dia risposte su tutto e a tutti. Sarebbe il modo migliore per affossare quelle esperienze e per inseguire un’unità sulla carta che non avrebbe alcuna utilità pratica e nemmeno moltiplicherebbe la portata delle lotte sociali. Queste lotte bisogna intanto saperle riconoscere, aiutarle a crescere, a diffondersi, ad arrivare in tutte le zone della città – e del paese. «Adottarle» tutte, nella loro specificità, conoscerne e rispettarne gli obiettivi concreti e materiali per costruire insieme spazi condivisi dove mettere in piazza le esigenze sociali e la forza delle pratiche alternative. Perché il punto di forza di tutte queste esperienze non è solo la loro portata – almeno potenzialmente – conflittuale, ma la loro costante messa in atto di alternative dirette, dal basso, autogestite.
Sono proprio le proposte alternative per vivere in maniera differente la crisi pandemica, con una una scelta collettiva delle priorità e delle responsabilità che riprende la critica alle scelte confindustriali che hanno lasciato aperti quasi tutti i luoghi di lavoro, senza alcun controllo e nessuna riflessione sulla loro sicurezza, mentre si chiudevano i luoghi della socializzazione culturale e della formazione (quale sia stata la logica delle politiche governative lo spiega con chiarezza Marco Bersani su il manifesto).
Empatia in questa fase significa guardare con attenzione alla necessità di combattere i contagi, e per questo alzare forte la voce contro la vergogna di piani vaccinali traditi e in mano a «professionisti allo sbaraglio», in genere gli stessi che hanno affossato la sanità pubblica in questi anni. E allo stesso tempo – non domani, oggi – rivedere le scelte fatte ascoltando il disagio di chi soffre la chiusura dei luoghi di formazione e socializzazione che possono essere organizzati per lavorare in sicurezza, senza scaricare su chi ci lavora e chi li frequenta le mancanze politiche e amministrative.
Come spiegava Marco Polo al Kublai Khan, è un impegno di attenzione e apprendimento continui, come quello che abbiamo provato a sperimentare in questo anno. E in questo impegno ancora vogliamo «cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio». Ora, e «dopo» la crisi pandemica – sapendo che non sarà l’ultima crisi sociale che abbiamo di fronte e che per questo avremo necessità di quella durata e di quello spazio (e quegli spazi, pubblici e sociali).
* articolo pubblicato su https://jacobinitalia.it/oltre-il-lockdown/