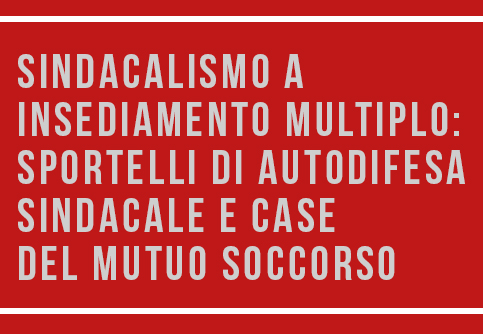La resistenza invisibile dei braccianti
di Martina Lo Cascio
Non è vero che nei ghetti del sud Italia non cambia nulla. Ci sono lotte e processi normativi, insieme alla maggiore consapevolezza di chi acquista
La notte del 30 settembre le fiamme divampano per ore, il ghetto di Campobello di Mazara brucia lentamente davanti all’impotenza di centinaia di persone che l’hanno pazientemente costruito, custodito, organizzato.
Può sembrare difficile pensare che delle baracche all’interno di un’ex fabbrica di calcestruzzi possano essere state la casa di qualcuno, ma è così da quando nel marzo 2018 lo storico insediamento informale di Erbe Bianche è stato sgomberato con l’intento di invogliare i braccianti con i documenti a spostarsi nella prima tendopoli istituzionale, presso il parcheggio dell’ex oleificio Fontane d’oro. Gli sgomberi dei ghetti sono stati solitamente preceduti o affiancati da una serie di interventi istituzionali, istituendo tendopoli e centri di accoglienza nelle zone adiacenti ai campi di raccolta. Una di queste ultime misure a livello nazionale è stato il Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento in agricoltura del 2017, firmato dai ministeri del lavoro, dell’Interno e delle politiche agricole, insieme a cinque regioni del sud Italia, i sindacati confederali, le organizzazioni datoriali e altri soggetti del terzo settore. La firma del Protocollo ha dato avvio a una nuova stagione in cui le istituzioni, allineate con organizzazioni datoriali, sindacali e della società civile, dichiarano di impegnarsi a risolvere il problema abitativo dei braccianti – inquadrato soprattutto come un problema di igiene e sicurezza – ricollocando la forza lavoro presente negli insediamenti informali in centri d’accoglienza o «campi» istituiti grazie all’accordo con le Prefetture. Strumenti e retoriche potenziati e ribaditi prima con il Piano Triennale (2020-2022) del Tavolo Caporalato, poi durante la pandemia con l’art.103 del decreto Rilancio.
Le connessioni tra le forme dell’abitare e la sfera produttiva sono numerose in tutte le enclaves agricole monocolturali e a Campobello sono state visibili quando in seguito allo sgombero dello storico insediamento di Erbe Bianche si è creato l’insediamento alla ex Calcestruzzi andato in fiamme pochi giorni fa. Dal 2008 al 2013 l’insediamento di Erbe Bianche è rimasto per lo più sconosciuto alla popolazione locale e ai media. È solo con la morte di Ousmane Diallo per lo scoppio di una bombola a gas, il 22 ottobre del 2013, che il luogo è diventato visibile.
8 anni dopo, lo scorso 30 settembre Omar Baldeh è morto bruciato vivo, perché anche lui viveva in un ghetto che ha fatto comodo a tutti: nascosto, lontano dai centri abitati di Castelvetrano e Campobello di Mazara, fuori dallo stato di diritto ma dentro il mercato del lavoro che regge l’economia dell’area.
Questa storia viene narrata da molteplici punti di vista: quello di due sindaci di due piccoli comuni in provincia di Trapani; degli olivicoltori piccolissimi, medi e grandi; dei trasformatori noti come «commercianti napoletani»; dei campobellesi, quelli del quartiere popolare di Erbe Bianche che per anni hanno convissuto in estrema difficoltà con i lavoratori o ancora dei benpensanti e dei massoni. Ma il punto di vista assente resta sempre quello di lavoratori e lavoratrici migranti.
La filiera dell’olivicoltura locale
La zona in questione è caratterizzata dalla monocoltura olivicola dai primi anni Novanta, con una parcellizzazione del tessuto economico, infatti gli olivicoltori sono circa 5000 di cui più del 90% possiede una superficie di soli 2 ettari. Dalla fine dello stesso decennio si sono sviluppati i percorsi di valorizzazione in seno ai consorzi di tutela che hanno portato alla nascita di due certificazioni di origine protetta, una per l’olio e l’altra per l’oliva da tavola. Questa possibilità è stata disertata dalla quasi totalità degli olivicoltori, infatti solo poche decine hanno aderito. La maggior parte dei profitti sul territorio sono a vantaggio di pochi trasformatori e delle catene della grande distribuzione organizzata, contestualmente gli olivicoltori svendono il loro prodotto e i lavoratori giornalieri sono sottopagati e a cottimo.
Per quanto concerne la manodopera, è diventata salariata sin dai primi anni Novanta, secondo la tendenza del resto dell’Europa meridionale che ha visto trasformare la gestione delle aziende da familiare a imprenditoriale, e inserirsi via via in catene extralocali e globali. Prima erano i tunisini a raccogliere le olive, poi agli inizi degli anni 2000 sono pian piano arrivati i subsahariani, in particolare senegalesi e perlopiù murid che è la componente protagonista del percorso di sindacalizzazione e di queste giornate di lotta.
I braccianti prendono parola
I braccianti hanno preso la parola in modo determinato e forte la stessa notte in cui nell’incendio hanno perso risparmi, vestiti e documenti a causa dell’incuria strutturale che ha determinato il ritardo nei soccorsi e la mancanza di fonti d’acqua per poter domare le fiamme. Lo shock delle prime ore ha lasciato il posto alla rabbia lucida. «È morto un fratello, siete stati qui ore fermi e non avete chiesto né il suo nome nè come stiamo», hanno urlato al sindaco Giuseppe Castiglione, e poi sottovoce tra loro: «Domani mattina blocchiamo tutto, a volte non riusciamo a essere uniti per le differenti condizioni ma domani non ci ferma nessuno, si parte alle 7.30!».
Come attivisti di Contadinazioni e della casa del mutuo soccorso Fuori Mercato alle 7.30 eravamo pronti a sostenerli, ma con la luce del giorno sembrava tornata la normalità, la rassegnazione, forse la disperazione che si materializzava davanti ai nostri occhi tra i cumuli di cenere e fumo ancora vivo. Quando vediamo arrivare qualche «padrone», così lo chiamano i braccianti, a cercare «manodopera» come se nulla fosse, un po’ si stringe il cuore per quella che sembra una mancata protesta. Un compagno porta delle casse d’acqua, la distribuiamo insieme alle mascherine che speriamo ci proteggano anche dalla diossina. Improvvisamente da via Dakar arrivano decine di braccianti che urlano «Blocchiamo tutto!». Ci spiegano di aver sentito che la soluzione istituzionale che si prospetta è una ricollocazione in albergo: è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Ancora una volta dopo 8 anni di ricerca etnografica e militanza a sostegno dei braccianti, impariamo l’ascolto, la necessità di riconoscere modalità e forme organizzative per diventare solo dopo solidali, come strumenti per le lotte diverse che si intrecciano. La calma mattutina ci aveva depresso, non avevamo capito che stavano aspettando un confronto con le istituzioni per agire una risposta.
Al di fuori del ghetto l’immondizia che straborda in via Selinunte, diventata una comoda discarica indifferenziata anche per campobellesi e castelvetranesi, è riciclata per costruire in pochi minuti un’estesa barricata. Si bloccano macchine, camion e trattori, e le prime parole dei braccianti sono: «Non vogliamo nessun albergo!».
Dopo un po’ Fallou si avvicina a noi e dice: «Riusciamo a trovare dei giornalisti che scrivono proprio quello che diciamo noi?». Lanciamo un appello tra i nostri contatti e la diretta dalla nostra pagina facebook per rendere pubblica la loro voce: «Noi non vogliamo aiuto, vogliamo solo due cose semplici: non vogliamo andare in albergo, vogliamo andare là dove eravamo gli altri anni, se non ci fate questo favore restiamo qui e blocchiamo la strada. Noi non siamo animali, siamo scappati dal nostro paese per trovare qualcosa per le nostre famiglie. Se veniamo qua per lavorare i castelvetranesi e i campobellesi devono ascoltare quali sono i nostri problemi».
Qualcuno dei bianchi presenti si avvicina timidamente per dire che alle 12 ci sarà un tavolo tecnico i cui esiti sarebbe importante aspettare. «Bene, allora alle 12 partiamo con un corteo, siamo stanchi di aspettare parole, vogliamo vedere i fatti». Sebbene indecisi se attendere il pane e nutella che hanno commissionato ad alcuni solidali in supporto, inizia il corteo lungo via Selinunte verso il centro abitato di Campobello di Mazara. Dal 2010, anno in cui si è creato il primo insediamento, è la prima volta che va in scena una forma esplicita di protesta dei lavoratori migranti. Il corteo si dirige all’ex oleificio Fontane d’oro, bene confiscato a un prestanome di Matteo Messina Denaro, che negli anni è stato teatro di diverse sperimentazioni abitative prima e speculazioni poi. I braccianti scelgono Fontane d’oro come luogo d’approdo del corteo forse perché è un luogo da cui sono stati cacciati tanti anni fa, che gode di acqua, luce, di uno strato di cemento che li protegge dal fango ed è più vicino al centro abitato. Giunti a destinazione affermano: «Abbiamo detto tutto chiaro da ieri, anzi da prima: o rimaniamo qua o non raccogliamo olive e si rovina tutta Campobello di Mazara. Siamo stanchi di parlare, vogliamo rimanere qua e non vogliamo andare da nessun’altra parte e non vogliamo dividerci perché siamo fratelli», ripetono più volte. «I sindaci non devono fare un gioco con noi perché se giochiamo vinciamo noi, perché sappiamo il nostro valore, abbiamo una pelle che non si brucia mai e sempre diventa nera mentre voi bianchi ogni estate cercate una crema per abbronzarvi per diventare neri, quindi nero è bello. Non siamo animali. Quello che è successo oggi, un nostro fratello morto, non lo dimenticheremo mai».
Dopo aver mangiato il tanto atteso pane e nutella, iniziano a organizzarsi per affrontare la notte. Il giorno dopo ci riferiscono che da ore, sono in trattativa con il tavolo tecnico delle istituzioni, che attraverso le forze dell’ordine chiedono ai braccianti di smontare le tende per permettere alla Croce Rossa di installarsi. La risposta è netta: nessuno smonta nulla. Dopo ore l’ultimo tentativo di mediazione è quello di spostare le tende dietro l’edificio dell’oleificio per permettere una convivenza accettabile con la Croce Rossa. Questa proposta genera un confronto acceso che si scioglie, infine, molto serenamente: nessuno ha intenzione di rinunciare alla propria autonomia in cambio di un panino o dei servizi della Croce Rossa alla quale viene riferito di desistere dal fare un ingresso di qualsiasi tipo.
Questa scelta, che in quegli attimi sembra esser presa in modo naturale, è straordinaria perché mette al centro un tema cardine della politicizzazione del lavoro agricolo bracciantile: l’autonomia, che non va tradita in cambio di nessuna offerta o servizio. Presa questa decisione, i braccianti si riuniscono per capire come procedere e organizzarsi, poi arrivano da noi per chiederci in che modo possiamo renderci utili. Mettiamo a loro disposizione il fondo della campagna Portiamo l’acqua al ghetto e decidono di comprare tende e cibo per tutti.
L’autogestione della lotta
Inizia un altro ritmo, quello dell’autogestione. Si costituiscono tre gruppi operativi: chi parte per trovare dei materassi, chi per comprare delle tende, chi del cibo diverso da quello che hanno mangiato in questi due giorni di emergenza. Un altro gruppo lavora sui documenti con gli avvocati e un altro ancora si occupa di fare una lista in base alle diverse esigenze. La sera nel piazzale avviene la distribuzione autogestita. Per chi ha assunto questo ruolo è faticoso ma gratificante perché è frutto di una scelta condivisa, e così la fatica e la fame lasciano il posto all’euforia di avercela fatta da soli. Con dei gesti semplici e forti hanno risposto a chi chiedeva: «Ma non avete fame? E allora perché non fate entrare la Croce Rossa?». La sera si chiude con le forze dell’ordine che salutano dicendo «Appena accendete un fuoco vi sgomberiamo». Ma l’indomani il cantiere continua le cucine autorganizzate che sono il secondo passo della presa di parola.
Il giorno dopo un via vai di bianchi portavoce e portatori di interessi si avvicinano a noi per mandarci un messaggio esplicito e uno implicito: il primo è «non possono gestirsi da soli, è evidente. Quindi perché non fanno entrare la Croce Rossa?»; il secondo è «siete voi i responsabili di tutto ciò». Il sotteso è la negazione ancora una volta della volontà dei lavoratori stessi, non riconoscono il fatto che hanno rifiutato il ricatto del cibo e della tenda perché stanchi di ricevere sempre le stesse proposte dopo una tragedia appena successa proprio a causa di quello stesso approccio emergenziale.
Nella storia di questi dieci anni l’intervento emergenziale apparentemente proposto con l’intento di migliorare le dure condizioni di vita dei e delle braccianti, ha anche puntato a «normalizzare» l’abitare sul territorio, riabilitando l’immagine delle istituzioni locali, delle aziende e, più in generale, della produzione agricola Made in Italy. Muovendosi all’interno del paradigma dell’emergenza e mutuando dispositivi da vecchi e nuovi modelli di gestione sia dei lavoratori ospiti che dei migranti forzati, la manodopera stagionale viene alloggiata in campi e tendopoli. Campi che, con le parole di Michel Agier (2018), possono essere definiti spazi di care, cure and control, ossia spazi al cui interno le pratiche umanitarie non possono essere disgiunte da quelle di controllo. Solitamente per godere dell’offerta di una serie di servizi che migliorano indubbiamente la vita quotidiana (l’accesso all’acqua potabile e calda, la presenza di materassi, la creazione di presidi sanitari, ecc.) si deve sottostare a un regime di controllo (accertamento dell’identità e della regolarità dei documenti; controllo della vita sociale e azzeramento delle possibilità di autogestire il cibo ecc.).
Sabato 2 ottobre, il terzo lunghissimo giorno di lotta è ormai rodato: alle 18 si interrompono i lavori per un’assemblea che stabilisce i punti della conferenza stampa dell’indomani mattina e si condivide la storia e la condanna di Mimmo Lucano a cui viene mandato un messaggio di solidarietà. La conferenza stampa è seguita da compagni e solidali dalla diretta facebook della pagina di Contadinazioni, gli interventi sono cinque e mettono al centro la narrazione dei fatti, la necessità dei documenti per tutti e tutte, sia per chi li ha persi sia per chi vive a Campobello di Mazara e non li ha più pur continuando a lavorare in campagna, le case per chi vuole rimanere, il contratto di lavoro per la sicurezza e per il rinnovo dei documenti e infine la richiesta di essere lasciati in pace, liberi, per vivere in autorganizzazione per tutta la stagione olivicola.
Il paradosso è che durante la conferenza stampa arrivano volontari di altre associazioni pieni di cibo da scaricare ma senza alcun interesse ad ascoltare le rivendicazioni espresse pochi metri più in là dai lavoratori. Chi tra i lavoratori si è occupato della distribuzione urla verso di loro: «Non vogliamo il vostro cibo, non vogliamo il vostro aiuto». Alcune associazioni, in accordo con i tavoli tecnici, scelgono allora di prendere le distanze da quella che nei giornali locali viene definita come «un’occupazione». Questa scelta di screditamento o criminalizzazione della pratica di riappropriazione di uno spazio e di chi la sostiene, tradisce l’impossibilità di un sistema di mettersi in discussione a partire dal riconoscimento dei braccianti stessi, perché basato semplicemente su un doppio atteggiamento da un lato di vittimizzazione di questi dall’altro dal controllo funzionale al disciplinamento necessario al mantenimento di un sistema produttivo basato sui profitti per pochi.
Le resistenze invisibili agli occhi
Gli avvenimenti a Campobello di Mazara ci impongono di non cadere nella trappola che oscilla tra la denuncia dello scandalo e la rassegnazione del «non cambia mai nulla». Non è vero che non è cambiato nulla nei ghetti nel sud Italia da quando sono stati posti sotto i riflettori dalla rivolta di Rosarno: sono proliferati gli interventi normativi a livello nazionale e territoriale, è cresciuta la consapevolezza del legame tra città e campagne da parte dei consumatori, sono nati numerosi progetti solidali contro lo sfruttamento e campagne di sensibilizzazione della stessa Grande distribuzione organizzata (Gdo) che è l’attore dominante di un sistema che si basa sulla flessibilità e il controllo della forza lavoro migrante. Non è vero che non è cambiato nulla perchè nonostante tutto questo le condizioni dei lavoratori sono spesso cambiate e in peggio.
Quanto fatto dai lavoratori migranti in questi giorni chiama in causa tutti noi professionisti, esperti dell’ambito o attivisti. Interroga il significato dell’essere alleati, quali tipo di azioni, metodi, organizzazioni siano necessarie e utili. Il presupposto è riconoscere che delle forme di organizzazione e di r-esistenza spesso invisibili agli occhi di studiosi, attivisti o sindacati, esistono. Sono le forme autorganizzate di vita negli insediamenti informali, come quella rivendicata questa volta esplicitamente con la riappropriazione e allestimento di Fontane d’oro, esistono e occorre mettersi in ascolto e a disposizione delle istanze che emergono da questi contesti. Sostenere materialmente queste pratiche e dare risposte concrete e materiali, come è stato con la campagna Portiamo l’acqua al ghetto, ha consolidato nei braccianti la fiducia e la conapevolezza di avere a fianco degli alleati su cui poter contare.
Non bisogna rassegnarsi perché i braccianti, ancora una volta, ci hanno insegnato a cambiare ritmo, lingua, modalità d’ascolto, e che tutto ciò produce cambiamenti radicali: i braccianti per la prima volta, a Campobello di Mazara, hanno preso parola rifiutando le strumentalizzazioni sulla loro pelle, rivendicando il loro valore e potere. «O ci rispettate e ci pagate la cassetta 5 euro, o non lavoriamo più e voi morite di fame». L’essere al loro fianco dà linfa vitale all’altro necessario binario delle lotte che è il rafforzamento, la nascita, il consolidamento di alternative contadine di autogestione e autodeterminazione dei territori.
Per sostenere i braccianti di Campobello di Mazara: Gofundme oppure donazione diretta a Fuorimercato, Iban IT79D 0838633 910000000470387 Banca credito cooperativo di Binasco, filiale di Trezzano s/N Causale: SOS BRACCIANTI DI CAMPOBELLO DI MAZARA.